Gli scienziati ed il Regime fascista
Roberto Renzetti
1 – PREMESSA
Ho più volte fatto la storia della ricerca fisica in Italia attraverso la storia della Scuola di Roma, del gruppo di Fermi che operò in epoca fascista. Si trattava della rinascita di una scuola di fisica dopo 300 anni, dopo Galileo. L’entusiasmo che ponevo nel trattare tale vicenda mi aveva fatto mettere da parte il resto della ricerca scientifica che rappresenta nel suo insieme l’aspetto quantitativamente più rilevante. Dopo aver visto cosa facevano altri Paesi nel periodo compreso tra le due guerre, è utile dare un quadro, almeno nelle sue linee generali, di cosa accadeva in Italia.
Visto che la trattazione non è specialistica, salvo casi speciali, non vi saranno note che rimandano a quei testi da dove le notizie sono state tratte. Quei testi avranno invece posto in bibliografia dove oltre a testi specifici di carattere specialistico riporterò anche testi con impostazione generale che inquadrano il periodo storico in oggetto.
2 – LA RICERCA FISICA IN EUROPA SUL FINIRE DEL XIX ED AGLI INIZI DEL XX SECOLO
In estrema sintesi la situazione della fisica si presentava nei seguenti termini. Innanzitutto vi erano tre Paesi che avevano in mano gran parte della ricerca di punta. La Gran Bretagna era certamente la prima potenza scientifica per la quantità e la qualità dei lavori prodotti. La Germania veniva emergendo possente a partire dal momento della sua unità (1870) sostenuta anche da una importantissima eredità degli stati preunitari (anche se brevissimamente, occorre dire che fu la politica scolastica che da una parte permise alla Germania di crescere a fronte del declino sempre maggiore della Gran Bretagna: nel primo Paese la scuola divenne pubblica e sostenuta da una importantissima politica di borse di studio, mentre nel secondo era, come è ancora, affidata a College in gran parte privati che selezionano a priori in base al censo). La Francia, che pure aveva rappresentato dei momenti fondamentali nella ricerca (soprattutto durante e dopo la Rivoluzione che aveva dato vita a quelle Scuole Politecniche che ancora oggi sono un vanto per quel Paese), andava perdendo palesemente terreno. A questi Paesi ne vanno aggiunti altri. L’Austria-Ungheria aveva costruito una fecondissima scuola di fisica. L’Olanda, la Svezia, la Danimarca avevano sempre tenuto alto il livello della loro ricerca. Anche la Russia aveva una importante tradizione iniziata dalla illuminata Caterina. Mancavano e mancano certamente all’appello Spagna e Portogallo, i due Paesi in cui l’oppressione della Chiesa di Roma fu più forte (ma su questo tornerò quando parlerò dell’Italia).
La ricerca abbarcava tutti i più svariati campi, ma era centrata in problematiche che avevano portato a maturazione questioni cruciali.
L’elettromagnetismo era ad un punto fondamentale di maturazione. Tra l’altro l’ottica, che sembrava un capitolo chiuso su se stesso, ritrovò nuovo impulso dalla teoria di Maxwell (luce come fenomeno elettromagnetico). Particolarmente era restato aperto il problema che lo stesso Maxwell aveva individuato nella sua lettera a Todd pubblicata postuma: la necessità di evidenziare la presenza del supposto etere che doveva, nella teoria, essere “sostegno” delle onde elettromagnetiche; ciò sarebbe dovuto avvenire mediante esperienze che misurassero la velocità della luce su un tragitto andata e ritorno sulla Terra (in un caso il moto si sarebbe sommato a quello dell’etere, nell’altro sottratto, con il risultato che la velocità in oggetto avrebbe dovuto dare risultati diversi, di pochissimo, ma diversi). Su questa importante branca della fisica certamente i più grandi contributi venivano dalla Gran Bretagna e dalla Germania (anche l’Olanda si era innestata con i lavori di Lorentz, l’Austria-Ungheria con Doppler e Mach, la Francia con Poincaré). Sul finire del secolo XIX fa anche la sua comparsa la fisica degli USA (precedentemente rappresentata dai soli lavori di Franklin ed Henry). Il guardiamarina Michelson si recò a studiare a Berlino e lì realizzò l’esperienza auspicata da Maxwell: non si trovò la differenza prevista nella velocità della luce. Prima di lasciare gli USA un brevissimo cenno alle problematiche di questo Paese. Un gigante privo di mano d’opera. I problemi più urgenti erano di tipo tecnologico e su questo essenzialmente si lavorò: meccanizzazione del lavoro nei campi e nelle fabbriche. Questo portò a tecnologie avanzate in campo agricolo, nelle macchine utensili, nelle comunicazioni, nei trasporti che saranno poi alla base della forte crescita di quel Paese (uno dei tecnici più noti che merita di essere ricordato è Edison). L’Europa viveva problemi opposti: molte braccia e poco lavoro.
Naturalmente non mi dimentico di Guglielmo Marconi in Italia. Il problema è che il nostro non era uno scienziato ma un validissimo tecnico ed eccellente empirico. In nessuna storia della fisica è riportato il suo contributo ed egli stesso non ha lasciato nessuno scritto teorico in cui si capisse da dove partiva per fare le sue ricerche; restano solo i suoi discorsi in cerimonie ufficiali come “scienziato” del regime. Un vero scienziato che in Italia si occupò di elettromagnetismo, con un qualche successo e sulla scia dei lavori di Hertz, fu il bolognese Augusto Righi.
Altri studi avanzati ed alla frontiera erano quelli in termodinamica. Anche qui la Gran Bretagna (Joule, Maxwell, Andrews, Dewar,…), insieme alla Germania (Mayer, Clausius, Wien, Planck, …) ed all’Austria-Ungheria (Stefan, Boltzmann) erano i Paesi più avanzati (agli inizi del XX secolo si inseriranno i fondamentali contributi di termodinamica statistica dello statunitense Gibbs). Un problema che qui stava creando scompiglio era l’intersezione di queste ricerche con quelle di spettroscopia atomica iniziate verso la metà del XIX secolo dal tedesco Kirchhoff. Nessuna teoria veniva a capo dei dati sperimentali relativi al “corpo nero” oltre a non riuscire a comprendere il come si generassero le linee spettrali.
Sul finire del secolo insieme a queste “due nubi oscure” (esistenza dell’etere e risultato “negativo” dell’esperienza di Michelson; incapacità di spiegare il corpo nero) vi era un altro problema sperimentale alla ricerca di una spiegazione teorica: l'”effetto fotoelettrico”, scoperto da Hertz come disturbo sperimentale ma ancora sfuggente ad ogni spiegazione. Inoltre, in Gran Bretagna, J.J. Thomson aveva “scoperto” l’elettrone (1897) e ne aveva misurate carica e massa (è la prima particella che compare nel mondo della fisica). In Francia H. Becquerel aveva casualmente scoperto la radioattività (1896): un pezzo di minerale (sali di uranio) che gli era stato portato in regalo da un amico di ritorno dall’Africa, aveva la proprietà di impressionare lastre fotografiche. Sempre in Francia, Pierre e Maria Curie (di origine polacca) scoprono altri elementi radioattivi come il torio, il polonio, il radio (1898). Ancora in Francia P. Villard scopre la radiazione gamma (1900) dopo che Rutherford in Gran Bretagna aveva scoperto (1899) i raggi alfa e beta. In Germania, Roentgen aveva scoperto strane radiazioni (le X) provenienti da un tubo a vuoto in particolari condizioni.
In ognuno dei Paesi di cui abbiamo parlato si era all’interno di queste problematiche con scuole di pensiero e di ricerca avanzatissime. Vediamo qualche risultato che viene fuori dalle problematiche che abbiamo evidenziato.
Nel 1900 Planck fa una ipotesi che sconvolge l’intero modo di concepire l’energia in fisica: essa è quantizzata, si distribuisce per quantità discrete e non in modo continuo (vedi il lavoro su Planck). La scoperta (che poi si presenta al suo primo apparire come un artificio matematico) farà discutere, anche in modo accanito, ma con quel modo di interpretare le cose si raccoglieranno subito successi in vari altri campi della fisica (essenzialmente atomica).
Nel 1905 Einstein pubblica tre suoi famosi lavori che daranno una spallata a molte delle concezioni del secolo che si era appena chiuso. Intanto, con l’uso dei “quanti” di Planck, fornisce una semplice spiegazione dell’effetto fotoelettrico. Fornisce poi la spiegazione di un altro fenomeno che circa 50 anni prima aveva scoperto il medico britannico Brown, il moto browniano, e che fino ad allora non era mai stato capito risultando di grave impaccio ad uno dei principi più importanti della termodinamica (dal disordine si crea ordine! È una violazione del 2º principio che Einstein spiega mediante la ‘teoria delle fluttuazioni’). Infine si sbarazza dell’etere con “un colpo di penna”. Ha il coraggio di rivedere i principi fondamentali della fisica che si erano affermati da Galileo e Newton. La meccanica, che nessuno avrebbe osato toccare, viene rivista nei suoi concetti fondamentali: simultaneità, spazio, tempo, lunghezze, … È la nascita della impropriamente chiamata “Teoria della relatività” che proprio per questo nome darà adito alle speculazioni di ignoranti vari, soprattutto tra i bigotti cattolici che allegramente confonderanno relatività con relativismo (la cosa poi faceva il gioco di chi poteva parlare della fisica “ebrea” da opporre al sano ed incorruttibile pensiero – sic! – cristiano). In realtà il lavoro di Einstein ha per titolo “L’elettrodinamica dei corpi in movimento” ed è un lavoro che, come osservò Planck, non ricerca ciò che nel mondo fisico varia, ma ciò che in esso resta invariante (come ad esempio la velocità della luce).
Tra il 1906 ed il 1909 il britannico Rutherford prova che i raggi alfa sono particelle cariche positivamente. Nel 1909 sempre Rutherford, con Geiger e Mardsen, scoprono il nucleo atomico e nel 1911 Rutherford fornisce un primo modello atomico (sarà lo stesso Rutherford, nel 1913, ad ipotizzare che il nucleo è costituito da protoni, particelle dotate di carica positiva). Nel 1913 il danese Bohr, utilizzando di nuovo i quanti di Planck, fornisce un nuovo modello atomico che (con gli aggiustamenti del tedesco Sommerfeld -1916 – ) spiegherà brillantemente gli spettri atomici ed aprirà la strada allo studio della fisica atomica superando molti dei problemi che il precedente modello poneva. Intanto, tra il 1910 ed il 1913, i britannici J.J. Thomson e F.W. Aston scoprono l’isotopia (anche se non sanno fornirne una spiegazione che non potrà venire fino a quando, nel 1932, il britannico James Chadwick non scoprirà l’esistenza del neutrone).
3 – LA SITUAZIONE ITALIANA
In questo disastro, tanto minore quanto più ci si allontanava da Roma, c’era una parte di ricerca che vedeva l’insieme degli stati preunitari al livello delle ricerche di punta in altri Paesi. Si tratta della matematica e questo fatto è di grande rilievo per ciò che servirà da sostegno agli sviluppi della fisica. Basta ricordare qualche nome di giganti italiani in questo campo: Lagrange, Peano, Cremona, Dini, Vailati, Ruffini, Ricci Curbastro, Levi Civita, Volterra, Ugo Amaldi, Enriques, Castelnuovo, Severi. La nostra matematica presentava comunque lacune in alcuni settori che poi si riveleranno strategici: l’algebra astratta (che sarà introdotta in Italia intorno al 1955 da Lucio Lombardo Radice) e la logica.
Tanto per completare il quadro con i fisici che l’Italia nel suo insieme poteva vantare, si può vedere l’ampia rassegna che in epoca di retorica fascista fu fatta dal fisico G. Polvani (si veda: “Un secolo di progresso scientifico italiano”, SIPS, 1939, Vol. I).
Con l’Unità d’Italia si trattò di rimettere insieme varie tradizioni di Stati preunitari, di costruire una scuola pubblica che avesse caratteristiche unitarie, si tentò di eliminare la pletora di università che erano nate per dar lustro e cattedre ma che non producevano nulla. Il Ministro della Pubblica Istruzione di uno dei primi governi unitari, il fisico Matteucci (l’altro fisico alla Pubblica Istruzione sarà Orso Mario Corbino, di cui parleremo), ebbe a dire che in Italia è più facile spostare la capitale che non chiudere una università. Il suo piano di razionalizzazione ebbe però almeno un successo: la creazione (da fondamenta antiquate) di una Scuola di elevatissimo prestigio, la Scuola Normale Superiore di Pisa.
Con una economia non certamente florida, con una politica di tipo coloniale del Nord Ovest industrializzato rispetto al Sud agricolo, fu assai difficile riuscire a trarre le fila di un discorso che avesse una qualche premessa comune. Tra l’altro si affossarono esperienze culturali importanti come ad esempio quella di Napoli che, da fiorente capitale, anche culturale, fu degradata a provincia. Comunque si riuscì piano piano a scolarizzare una grande percentuale di italiani. Questa scolarizzazione fu pubblica ed aveva come obiettivo l’uniformità dei programmi di studio proprio al fine di fare l’unità a partire dai cittadini.
In questo clima si innestano le vicende di Enrico Fermi che nasce nel 1901, a 30 anni dall’Unità d’Italia, una generazione dopo tale Unità e che inizierà a produrre intorno al primo quarto di secolo, due generazioni dopo l’Unità, quando ci si apprestava a rimettere in gioco la Chiesa con il Concordato (1929).
4 – LA FISICA IN ITALIA AI PRIMI DEL NOVECENTO: UNA PANORAMICA
Prima di iniziare a fornire i caratteri salienti dell’argomento, avverto che il mio interesse principale sarà per la fisica con ampi riferimenti alla matematica ed alla chimica. Tralascio, per motivi di competenza, questioni riguardanti le altre discipline scientifiche.
Nelle vicende della fisica italiana del Settecento ed Ottocento vi era, oltre al condizionamento censorio ed oscurantista, un carattere esterno che determinò il suo sviluppo. A parte qualche modesto finanziamento alla ricerca da contati sovrani di passaggio ed illuminati, la mancanza di fondi impedì il crearsi si scuole che avrebbero permesso di creare una continuità ed una moltiplicazione degli addetti alla ricerca. Lo scienziato veniva fuori in modo casuale per una personale disposizione che doveva però essere accompagnata da almeno una discreta situazione economica personale. Quando quest’ultima eventualità non era verificata allora lo scienziato doveva “arrangiarsi” dedicando il suo lavoro ad “invenzioni” spendibili sul mercato, cioè ad oggetti o strumenti che altri ricercatori avrebbero comprato permettendo all’inventore di continuare il proprio lavoro di scienziato. Quanto ora detto, unito al fatto che non esisteva il mestiere dello scienziato, nel senso che non vi erano persone, a parte le poche che insegnavano, pagate per fare scienza, comportò una conseguenza alla lunga ineluttabile: la scienza italiana si indirizzava verso lo sperimentalismo e le attività pratiche, tralasciando del tutto la parte teorica di ogni disciplina.
Nell’ambito della fisica, come ho accennato nel paragrafo 2, nella seconda metà dell’Ottocento si era verificata una mutazione di estrema importanza in qualche modo legata alle esigenze di efficienza che si accompagnavano alla Rivoluzione Industriale. Galileo aveva ipotizzato il modo di lavorare di un ricercatore ed aveva strettamente connesso l’immaginazione, la teoria, con l’esperienza, con la verifica sperimentale di quanto ipotizzato. Tutto ciò aveva retto abbastanza fino a quando la richiesta di maggiore specializzazione aveva portato naturalmente ala divisione del lavoro tra il teorico e lo sperimentale. Fu proprio in quegli anni che nasceva la fisica teorica con i lavori alla base di ogni sviluppo successivo di personalità come Sadi Carnot, Maxwell, Clausius, Lorentz, Bohr, Planck, Einstein eccetera. Si può comprendere che questi personaggi, oltre a dare fondamentali contributi, crearono le basi per ogni sviluppo futuro della fisica (e non solo). L’elettromagnetismo nasce qui e pone le sue scoperte teoriche alla base dell’affermazione o meno di un ente come l’etere. Da qui discendono alcune premesse della relatività. Per altri versi anche la termodinamica ed i grandi sviluppi della teoria cinetica si fondano nei lavori di questi scienziati. Tali lavori, intersecandosi con quelli sulle scariche nei gas, portano alla teoria del corpo nero da cui verrà fuori la prima formulazione quantistica ed un grande contributo all’affermazione dei primi modelli atomici (nella discussione dei quali entrerà anche la relatività, nata altrove.
Disegnare in poche righe questo quadro serve solo per mostrare che ogni ricerca avanzata in Europa ruotava sulla fisica teorica che dette poi sviluppi clamorosi in fisica sperimentale. D’altra parte, in passato, era stata la fisica sperimentale o meglio addirittura l’empirismo ad essere cocchiero della fisica teorica (si pensi alle macchine termiche ed alle prime formulazioni della termodinamica). Ma per una sorta di mentalità che vuole risultati subito, il processo che parte dall’esperimento è inteso come produttivo, l’altro come dispendioso e poco produttivo. E quest’ultima posizione era quella radicatasi in Italia. Tanto radicata che l’Italia fu esclusa da questi dibattiti avanzatissimi tra tutte le scuole di fisica di maggior prestigio d’Europa, con gravi danni in termini di produttività, efficienza e crescita del Paese. In più in Italia si ebbero eminenti personalità, anche in ambito scientifico, che addirittura teorizzarono tutto questo, teorizzarono cioè il primato della scienza pratica su quella teorica.
E’ utile però fare riferimento a qualche fatto concreto per cogliere la distanza della ricerca tra Italia ed il resto d’Europa.
Tra la fine dell’Ottocento ed i primi anni del Novecento si sviluppò, con i lavori di J.J. Thomson, Rutherford e Bohr, la teoria atomica con l’elaborazione di vari modelli. In Italia l’atomo era utilizzato come una sorta di schema interpretativo “alla Dalton”, utile per spiegare vari fenomeni ma privo di struttura in modo che era indifferente la sua dimensione e le sue caratteristiche intrinseche. L’atomo della fisica era ben altro ed esso era il risultato di varie ricerche incentrate principalmente sui fenomeni spettroscopici e delle radiazioni catodiche. Eppure in Italia vi era una tradizione spettroscopica ma nessuno faceva riferimento al modello di Thomson per tentare una qualche spiegazione che introducesse le vibrazioni elettroniche alla base di quelle righe che comparivano negli spettri. Il più famoso tra gli spettroscopisti italiani, Luigi Puccianti, individuava l’origine delle righe nelle vibrazioni degli atomi-ioni positivi. E cosa sarebbero queste entità ? Dei meri nomi, artifici verbali, che almeno si sarebbero potuti sottomettere a trattamento teorico. Ma ciò era impedito anche dalla scarsa conoscenza della letteratura scientifica straniera e dei metodi di calcolo che erano diventati estremamente sofisticati. Solo un paio di fisici italiani avevano conoscenza degli ultimi sviluppi dell’elettromagnetismo elaborati da svariati fisici europei ed in grado di accompagnare le loro intense ricerche sperimentali con un degno ed a volte geniale apparato teorico, Antonio Garbasso di Firenze ed Orso Mario Corbino di Roma. Inutile dire che dietro questa situazione, quantomeno qualificabile come provinciale, vi erano cause storiche di scarsità totale di finanziamenti, scarsità di sbocchi professionali con la conseguenza di pochi studenti che si avvicinavano alle facoltà scientifiche, pochissime cattedre di fisica e nessuna di fisica teorica. Segrè scriveva che intorno al 1920 Corbino era l’unico fisico italiano aggiornato ed in grado di capire ed apprezzare la nuova fisica mentre tutti gli altri fisici rappresentativi delle diverse Università, con il pensionamento di Garbasso, erano non solo neutri rispetto a tale fisica, ma addirittura avversari. Agli inizi del secolo le scoperte si susseguivano a ritmo sempre più accelerato e ciò richiedeva aggiornamenti continui della strumentazione. Se solo si pensa ai fenomeni radioattivi, alla necessità di nuove strumentazioni e di materiali radioattivi da comprare, ci si rende conto di come fossero indispensabili finanziamenti continui per essere minimamente al passo. Queste considerazioni erano degli stessi Garbasso e Corbino che capivano tra l’altro come sarebbe stato illusorio avvicinarsi solo empiricamente ai vari nuovi fenomeni senza lo studio approfondito, anche qui, della nozione fisica di atomo emergente in ogni fenomeno all’epoca allo studio.
Alla vigilia della Prima Guerra Mondiale fu Antonino Lo Surdo il primo che introdusse in una discussione su un fenomeno fisico, la decomposizione delle righe spettrali per effetto di un campo elettrico, l’ipotesi atomica. La storia di questa vicenda è emblematica del provincialismo italiano. Lo Surdo aveva scoperto il fenomeno nel 1913 ma non lo aveva ritenuto d’interesse e quindi non aveva insistito su di esso ma, quando analogo fenomeno fu messo in evidenza da Johannes Stark qualche mese dopo, si affrettò a rivendicarne la primogenitura attraverso la rivista Nuovo Cimento. Altri fisici, tra i quali Garbasso, intervennero per motivi nazionalisti a sostegno di Lo Surdo ma l’aspetto più interessante è che venne riconosciuta dietro l’effetto (Stark-Lo Surdo) la necessità di una discussione della base teorica del fenomeno che era, ancora una volta, quella atomica (il modello di Rutherford nella forma di Bohr, come ebbe a scrivere Garbasso). Sembrerebbe che a questo punto si fosse realizzata un’apertura verso almeno una parte della fisica teorica. Invece tutto finì sulla citazione che Garbasso fece di Bohr.
Altro esempio di distanza da quanto si faceva in Europa lo fornisce il bolognese Augusto Righi che in qualche modo aveva dato una mano (prestando strumenti dell’Università al figlio di amici) a Guglielmo Marconi nelle sue prime esperienze di trasmissione radio. Nello studiare l’influenza del magnetismo sulle scariche elettriche inventò straordinarie teorie atomiche che, ad essere buoni, erano basate sul nulla teorico e sperimentale (uno ione positivo ed un elettrone che si avvicinano possono dar luogo a quest’ultimo che ruota come un satellite intorno al primo formando un sistema diverso da un atomo).
La relatività ebbe una storia in gran parte analoga ma per certi versi diversa soprattutto per il ruolo che ebbero i matematici. Nei dibattiti sorti sul problema dell’esistenza e della costituzione e dinamica dell’etere, le posizioni più avanzate che si ebbero in Italia erano quelle che sostenevano le ipotesi del fisico tedesco Abraham sulla natura elettromagnetica della massa dell’elettrone e della sua incomprimibilità. Il tutto avveniva però non tra scienziati che dessero contributi al dibattito ma da divulgatori che, almeno, facevano una qualche rassegna dei lavori che venivano realizzati in Europa. Nel 1907 compare per la prima volta il principio einsteniano di relatività in lavori di rassegna realizzati da Corbino e Levi Civita, il primo fisico ed il secondo fisico matematico. Inevitabilmente le discussioni finirono in ambiti filosofici con Corbino, schierato con Abraham, che vedeva nel principio di relatività un’ipotesi metafisica e con Levi Civita, sostenitore della teoria di Lorentz, più possibilista che vedeva in tale principio un ottimo strumento concettuale. In un mondo in cui la fisica aveva dignità se aveva carattere sperimentale, nel Congresso della Società Italiana per il Progresso della Scienza (SIPS) del 1911, fu il matematico Guido Castelnuovo che riportò i fisici alla loro ragione empirica e sperimentale: è l’idea di contemporaneità che ha valenza metafisica ed i positivisti non potevano accettarla. Difficile conciliare queste petizioni di principio con fisici sperimentali che usavano la metafisica dell’etere, come Righi che, nello stesso congresso, si pronunciò appassionatamente a favore dell’etere, entità indispensabile per la spiegazione di molti fenomeni, non citando neppure Einstein, se non altro per contraddirlo. Lo stesso Righi, nel 1920 a proposito degli sviluppi relativistici nella Relatività Generale, ebbe a lamentarsi con tono accorato cogliendo uno dei problemi più grandi che si avevano in Italia e certamente più sentiti, anche se esorcizzati con il silenzio: i fisici non conoscevano la matematica sviluppata ed utilizzata nelle epoche più recenti in Europa per trattare i problemi fisici, particolarmente teorici. Scriveva Righi: certamente non se ne avvantaggerebbe il progresso scientifico dell’umanità se i fondamenti della filosofia naturale non dovessero rimanere accessibili che a quei pochi privilegiati per i quali è agevole il maneggio dei complicati strumenti matematici. Dietro questa frase vi era una non velata polemica con i fisici matematici che invece avevano molta confidenza con la matematica utilizzata nella relatività generale e che erano in grado di discuterla e di apportare contributi. Particolarmente Levi Civita e Castelnuovo, con i loro contributi al calcolo assoluto, divennero interlocutori importanti sugli argomenti trattati. La polemica era invece molto grande ed anche dopo l’esperienza di Eddington, che inseguendo una eclisse di Sole in Cile aveva mostrato la curvatura subita dai raggi luminosi per effetto della massa del Sole, si esprimevano in gran parte nel ritenere non probante quella esperienza. Un solo giovanissimo fisico di 21 anni scrisse che da quei fenomeni relativistici era ipotizzabile estrarre grandi quantità di energia dai nuclei atomici. Era Enrico Fermi. Ed a lui si dovranno le prime aperture ed i primi contributi di assoluta rilevanza allo sviluppo della nuova fisica, a partire dal 1923. Ma su queste vicende, le uniche di grande rilievo fino al 1938, non mi soffermo perché le ho trattate altrove.
Per inquadrare lo stato della matematica, ccorre premettere un dato legato agli eventi storici del passato: mentre la fisica, l’astronomia e la chimica erano state soffocate in Italia perché più compromesse con il razionalismo illuminista e meno riconducibili a ideali classici, la stessa cosa non avvenne per la matematica, per le scienze naturali e per le scienze della vita (in quest’ultimo caso perché non era stata ancora enunciata la teoria di Darwin). È quindi naturale che, dietro a una tradizione consolidata, vi sia una maggior messe di raccolti. La matematica, poi, è svincolata dalle condizioni materiali della ricerca (servono solo libri, carta e penna!) ed è proprio la matematica ad ottenere i maggiori successi che riguardano: Una storia diversa è quella della matematica. Per sua natura di disciplina eminentemente teorica e quindi indipendente da particolari finanziamenti se non quelli occorrenti per pagare gli stipendi, essa era profondamente radicata in Italia e godeva di notevole prestigio internazionale. Inoltre si erano costituite delle scuole che avevano un buon numero di ricercatori, scuole che garantivano la continuità dei lavori anche in assenza di luminari. Famose furono: la scuola degli analisti pisani (tra i quali Betti, Beltrami, Dini che ebbero come alunni Vito Volterra e Pincherle); la scuola di geometria differenziale che ebbe origine ancora a Pisa (tra i matematici e fisici matematici di questa scuola vanno ricordati Fubini, Ricci-Curbastro ed il già citato Tullio Levi-Civita); la scuola di geometria algebrica (che annoverava Giuseppe Veronese, Corrado Segre, Guido Castelnuovo, Federigo Enriques, Fabio Conforto, Luigi Campedelli, Francesco Severi e Gino Fano); la scuola torinese di Giuseppe Peano che va anche ricordata per l’introduzione in Italia degli studi di logica; ed altre scuole che si formarono per il trasferimento di alcuni dei citati ma anche di altri da università ad università sull’intero territorio nazionale (è qui che diventa fondamentale una scuola: quando il personaggio di prestigio si allontana per andare a lavorare altrove, non si perde la tradizione di ricerca).
Nonostante questa fioritura agli inizi del Novecento si ebbe una certa decadenza soprattutto rispetto ad altre scuole europee che invece avevano avuto notevolissimi risultati. Certamente si formeranno ancora grandi matematici ma lavoreranno in un clima di isolamento, soprattutto internazionale, di modo che la matematica italiana sarà assente dagli sviluppi di quella gigantesca miniera algebrico-topologica che sarà elaborata in quegli anni in Germania e negli Usa e, più tardi, in Francia. Il rammarico non può che essere grande, se solo si pensa che le prime formulazioni sulla strada degli sviluppi futuri furono dovute a matematici italiani (ad esempio, Peano e collaboratori avevano fornito la prima formulazione assiomatica di spazio vettoriale; per non dire delle prime formulazioni dell’analisi funzionale astratta). Tutto ciò era stato avvertito da Volterra, prima che abbandonasse l’Italia per non aver accettato di sottomettersi al giuramento di fedeltà al regime, e anche da Tricomi che – comunque con soddisfazione – si compiaceva del fatto che la gran parte della produzione dei nostri matematici, lungi dall’essere applicativa, restava legata alla ricerca pura. Si misurava in quel periodo, come accennato, l’isolamento dell’Italia rispetto al resto d’Europa come abbiamo visto per la fisica. Mancarono ad esempio traduzioni di opere straniere. Inoltre una serie di circostanze fecero sì che da una parte gli studi matematici si isolavano sempre più rispetto all’evoluzione sociale del Paese e dall’altra che l’università diventava sempre più accademia che per sua natura respingeva i giovani talenti. A questo vi è da aggiungere che la non connessione tra le varie discipline originò uno spostamento degli studi della matematica proprio in un momento in cui cambiavano in senso opposto studi scientifici. Mentre la matematica tendeva ad orientarsi sempre più verso studi puri, meno applicativi, le altre scienze, come vedremo, si orientavano sempre più, anche per le esigenze che saranno autarchiche, verso ricerche applicative e le esigenze di produzione industriale.
Queste difficoltà della matematica, ma anche della fisica trovavano alimento anche nel clima filosofico che era dominante nel Paese. L’idealismo negava dignità conoscitiva alla scienza che relegava alla produzione di tecniche. In tal senso l’opera di Croce e Gentile fu nefasta anche se, per la verità, le loro idee non erano troppo distanti da quelle di alcuni scienziati come ad esempio Enriques. C’è comunque da giustificare i due filosofi idealisti per la loro scarsa conoscenza della scienza in perfetta linea con la cialtroneria della maggioranza dei filosofi italiani. D’altra parte se la scienza si presentava, come in Italia, con la costruzione di galvanometri o banchi ottici o radio o pile, era difficile intravedere, anche perché non in grado di leggerle, le elaborazioni, ad esempio, di Maxwell, Lorentz, Clausius, Einstein e Planck.
5 – CHIMICA ED INDUSTRIA IN ITALIA AI PRIMI DEL NOVECENTO: UNA PANORAMICA
Ai primi del Novecento si svilupparono nel Nord d’Italia svariate iniziative industriali che segneranno i successivi sviluppi economici del Paese. Da notare che tali iniziative nascevano in massima parte da imprenditori con accentuata preparazione tecnica. Scrive Luigi Cerruti in Chimica e chimici in Italia: 1820-1970 (inserito in La storia delle scienze):
Nel 1906 Cesare Sereno (1871-1952), scienziato, imprenditore e uomo di cultura, fondava l’Istituto Medico Farmacologico omonimo. Nel 1910 Guido Donegani (1877-1947) divenne amministratore delegato della Montecatini (fondata nel 1888), fino ad allora una modesta impresa produttrice di piombo e rame. Leopoldo Parodi Delfino (1875-1945), che dal 1904 produceva alcool dalla distillazione della melassa fermentata, nel 1912, in unione di capitali con il senatore genovese Giovanni Bombrini, aveva fondato l’impresa omonima e aveva cominciato a produrre esplosivi a Segni-Scalo. Nel 1915, infine, Roberto Lepetit (1865-1928), un chimico-imprenditore di grandi capacità, trasformava nella “Ledoga” l’impresa che il padre aveva avviata in val di Susa, e che nel 1898 aveva trasferita e ampliata a Garessio (Cuneo). […]
I migliori imprenditori erano tutti dotati di forte cultura tecnica (Lepetit, Serono, Morselli) ed erano intervenuti più volte sui problemi posti dal tumultuoso ampliamento della base produttiva, contrassegnato da eccessi speculativi e da scarsa efficienza nella conduzione degli impianti. La rivista dell’Associazione Chimica Industriale di Torino era stata la sede privilegiata del dibattito, che non aveva risparmiato né lo scarso coraggio innovativo degli imprenditori né le assurdità del sistema fiscale italiano. Tutto un atteggiamento fondamentale si era andato trasformando negli anni: all’accettazione tout court della ‘naturalità’ della condizione italiana di dipendenza dell’industria dai bisogni (arretrati) dell’agricoltura, si era sostituita una più precisa coscienza delle potenzialità di sviluppo dell’industria chimica più avanzata insite nell’esistenza di ampie competenze tecnico-scientifiche e di un vasto mercato interno, in cui già operavano settori importanti e discretamente avanzati sul piano internazionale come quello tessile. Nel pieno della guerra, su tutto questo si pronunciarono scienziati come Mario Giacomo Levi (1878-1954) ed Ettore Molinari (1867-1926). Nel 1917 si tenne a Milano un Convegno nazionale di chimica applicata e in questa sede Molinari, il nostro migliore chimico industriale dell’epoca, tenne un’ampia relazione, ricca di toni pacifisti (nel ’17!) e di indicazioni per la riconversione postbellica dell’industria chimica.
La mobilitazione dei chimici in funzione dell’economia di guerra e della guerra stessa fu ampia. Per gli aspetti industriali fu nominato dal governo un Comitato per le industrie chimiche presieduto da Ciamician, e comprendente tre altri scienziati, Nasini, Villavecchia e Levi, e due tecnici-imprenditori, Serono e Morselli […]. Ma il chimico che contribuì maggiormente alla mobilitazione industriale fu certamente Ettore Molinari: egli infatti diresse a Cengio lo sforzo colossale della Società Italiana Prodotti Esplodenti, volto a sopperire alle enormi necessità del nostro esercito. Coadiuvato da due figli, Henry e Vittorio, e da tecnici quali Ascanio Dumontel (1876-1950) e Eligio Foggiani (1888-1958), Molinari riuscì a moltiplicare di 25 volte la produzione degli esplosivi, confermando così l’utilità pratica delle sue ‘prediche’, prima dalla cattedra di chimica applicata della Società d’Incoraggiamento di Milano, poi da quella di chimica industriale del Politecnico. Ma questi successi non ci devono far dimenticare le barbare stragi della guerra, che Molinari denunciava apertamente. In particolare va menzionato il gravissimo ritardo con cui lo Stato Maggiore italiano volle e seppe provvedere alla difesa contro l’uso dei gas da combattimento da parte degli austriaci. I tedeschi avevano scatenato i primi attacchi con i gas nell’aprile del ’15; gli inglesi avevano iniziato la loro controffensiva chimica nel settembre successivo. Noi perdemmo 5000 uomini nell’attacco condotto con i gas dagli austriaci sul Monte San Michele il 29 gennaio 1916, a dieci mesi dal primo apparire della guerra chimica sui fronti occidentali.
Il primo dopoguerra portò allo scoperto molti problemi. La riconversione fu durissima: quasi 900 industrie fallirono. Vi furono imponenti crisi: agraria, tessile meccanica e siderurgica. Sul fronte della ricerca gli scienziati sperimentarono un profondo senso di frustrazione per la chiusura dei laboratori e la consapevolezza, prima inesistente, di alcune inalienabili esigenze. I reduci e le distruzioni crearono eserciti di disoccupati. Alcune industrie si erano comunque enormemente potenziate e riuscirono a passare indenni quel periodo, a volte addirittura guadagnandoci. Il consorzio siderurgico Uva si appropriò della Banca Commerciale e del Credito Italiano (1921): la Montecatini assorbì le due massime industrie produttrici di fosfati (1920); la Terni le sue attività all’elettricità, all’elettrochimica, alla meccanica; le imprese elettriche prosperarono – dati gli alti prezzi raggiunti dai combustibili – disponendo inoltre di un nuovo ampio tratto di arco alpino da imbrigliare; grandi incrementi ebbero la produzione di macchinario tessile, di macchine per cucire Necchi, di macchine per ufficio (Olivetti), di strumenti ottici, di prodotti di meccanica fine e di precisione; la società Snia (Società di navigazione italo-americana), di proprietà Agnelli (Fiat) e Gualino, entrò nel settore della seta artificiale (raion), assorbendo la Viscosa di Pavia. La Snia-Viscosa (1922) ebbe un successo eccezionale, di fronte al crollo dell’industria della seta naturale.
Sul fronte della scienza-ricerca la guerra aveva prodotto alcuni effetti negativi come il nazionalismo tecnico-scientifico, la politica autarchica, la retorica del primato scientifico italiano …; ma anche effetti che, almeno in una certa ottica, sono da ritenersi positivi: il valore pratico della scienza, la continuità dei rapporti scienza-industria.
La chimica, nei Paesi oltralpe, diventò sempre più impresa industriale con la quasi scomparsa del singolo ricercatore sostituito da gruppi anche numerosi di addetti. Ebbe un grande sviluppo la chimica organica a caccia di macromolecole e del miglioramento sintetico di quanto la natura offre (nacque così la chimica della cellulosa per la produzione di carta e fibre tessili, l’industria della gomma sintetica e la ricerca dei combustibili liquidi non derivati dal petrolio(1)). Tutto ciò veniva fortemente aiutato da tecniche fisiche inserite in ricerche chimiche: lo studio spettroscopico delle sostanze a varie frequenze, l’introduzione della diffrazione dei raggi X per lo studio dello stato solido.
In Italia è impossibile discutere di chimica senza far riferimento all’industria e, subito dopo il primo dopoguerra, non si poteva parlare di industria senza far riferimento al fascismo, all’autarchia ed alla guerra. Un quadro del comune sentire dei chimici nel periodo in considerazione può essere ricavato dal Convegno nazionale di Chimica Industriale che si tenne al Politecnico di Milano nell’aprile del 1924. Scrive Cerruti:
Il discorso inaugurale fu tenuto dall’ordinario di chimica generale del Politecnico, Giuseppe Bruni (1873-1946), allievo di Ciamician e cultore di molti temi avanzati di chimica fisica, parlò ad una settimana esatta dalle elezioni vinte da Mussolini (65 per cento dei voti) con la violenza delle camicie nere e dell’apparato dello Stato, già piegato ad esigenze di regime. L’argomento scelto da Bruni fu “La chimica nella preparazione e nella difesa nazionale“; iniziato con l’affermazione che la guerra era stata “una grande Università popolare all’aria aperta” in cui era stato insegnato “che cosa potesse la Chimica“, il discorso passò attraverso un’esaltazione del pensiero “incomparabilmente chiaro e profondo” del “Capo del Governo“, e si concluse con una dedica alla “difesa della patria” da parte delle “menti” dei chimici, “ferme e unite come le verghe del fascio per operare e per servire“. Bruni dovette aver trovato conferma di questo impegno quando tredici anni più tardi, nel settembre 1937 tenne un altro discorso generale, alla XXVI riunione della Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Il tema era più sobrio (“Prodotti naturali e prodotti sintetici“) ma Bruni, in camicia nera, trovò modo di celebrare con toni pagani le nuove funzioni che 1′ “eliochimica organica” di Ciamician poteva assumere nell’Impero conquistato da Mussolini. Ma la traccia più importante per cui ci preme seguire Bruni non sono i singoli discorsi quanto la sua ‘elezione’ a deputato nella XXVIII legislatura, in quanto essa permette di estendere il discorso ad aspetti più collettivi della comunità dei chimici. Come è noto, Mussolini mantenne la numerazione delle legislature dello Statuto albertino, ma le elezioni nel 1929 si svolsero su lista bloccata di quattrocento ‘candidati’ nominati dal Gran Consiglio del fascismo. Fra questi troviamo, oltre a Bruni, Enrico Belloni (1883-1938), chimico farmaceutico e dirigente dell’ACNA e della “Schiapparelli”, e Gian Alberto Blanc (1879-1966), un geochimico, nonché Donegani e Serono che abbiamo già incontrato. Nella successiva legislatura Bruni, Donegani e Serono vennero confermati, mentre la rappresentanza degli imprenditori-tecnici veniva rafforzata con la nomina di Morselli, allora al vertice della “Carlo Erba” e della “Caffaro”. Ciò che mi preme sottolineare è la presenza di Serono e di Morselli, uomini di provate capacità scientifiche e imprenditoriali, uomini rari nel contesto italiano che sembrano così coronare un impegno durato una generazione in favore di un rapporto avanzato fra scienza e industria, e fra industria e intervento statuale.
Il secondo caposcuola che dobbiamo seguire è Nicola Parravano (1883-1938). Chimico metallurgico e allievo prediletto di Paterno, la sua ‘presenza’ nella comunità dei chimici cresce nel tempo fino a divenire dominante alla fine degli anni Venti. Sue proprie tesi erano quelle della scienza come “forza sociale” e dello “scienziato fascista” come “uomo di cultura, tecnico applicatore ed individuo etico e politico” (discorso “Il Fascismo e la Scienza“, aprile 1936). […]
Il terzo scienziato, di grande valore, da prendere in considerazione è Livio Cambi (1885-1968), allievo di Ciamician e di Angeli. Coetaneo di Parravano, giunse ad un importante ruolo politico nel 1939 quando fu nominato rappresentante del Partito nazionale fascista nella Corporazione della siderurgia e metallurgia.
Tra le responsabilità maggiori dei chimici durante il ventennio fascista vi è certo quella di aver alimentato e giustificato in ogni modo la politica autarchica che sembrava concepita a partire dai sogni più improbabili della grande industria chimica. Certamente i chimici non furono i soli scienziati a corteggiare il regime, né le motivazioni di chi fra loro lo fece furono sempre le stesse. È infatti difficile valutare 1’adesione’ di Mario Giacomo Levi, il massimo tecnico di allora dei problemi dei combustibili. Levi nel ’37 era direttore dell’Istituto di chimica industriale del Politecnico di Milano e della Sezione combustibili ad esso annessa; in questa duplice veste alla già citata riunione della sips garantiva: “prossimamente la Nazione sarà in grado di prodursi i 4/5 dei carburanti necessari al suo consumo attuale“. L’8 giugno del 1938, un mese prima dell’inizio della campagna antisemita, facendo un resoconto del “X Congresso Internazionale e Romano”, Levi esalterà “l’Italia dell’era fascista” come “Nazione proletaria“.Nell’autunno” Levi doveva lasciare la cattedra, colpito dalle leggi razziali,ed iniziava un lungo e tormentato esilio, prima dalla ricerca e poi dal nostro Paese.
L’adesione al fascismo fu sentita spesso come una costrizione, e molti mantennero un atteggiamento riservato, ma solo uno fra tutti i chimici accademici rifiutò il giuramento di fedeltà nel 1933. Michele Giua (1889-1966) dovette abbandonare il posto di assistente presso l’Istituto di chimica industriale del Politecnico di Torino, ma poté continuare la sua opera scientifica presso una grande casa editrice di quella città, l’UTET.
Industria e Stato nella ricerca. I contributi disciplinari
Il senso di progressiva conquista che abbiamo percepito negli scritti citati nella sezione precedente aveva la sua giustificazione in una serie di importanti risultati ottenuti sia nel campo dello sviluppo dell’industria chimica più avanzata, sia in quello dell’organizzazione stessa della ricerca. In altri termini, i chimici percepivano l’efficacia del loro impegno.
Un giusto motivo d’orgoglio risiedeva nei processi per la sintesi dell’ammoniaca messi a punto da Luigi Casale (1882-1927) e da Giacomo Fauser (1892-1971). L’Italia degli anni Venti fu l’unico Paese al mondo ad avere due serie di brevetti pertinenti alla fissazione dell’azoto: per valutare la portata tecnologica ed economica di queste imprese innovative si deve tener conto che in questo campo negli Stati Uniti furono impiantate tecniche ‘indigene’ solo negli anni Trenta. Casale iniziò la diffusione mondiale dei suoi brevetti nel ’21, nello stesso anno in cui Fauser prese il suo primo brevetto sulla sintesi dell’ammoniaca. La Montecatini, sotto la guida di Donegani, era allora in piena espansione e nel 1923 essa avviò una lunga collaborazione con Fauser che nel 1932 sfociò nella fondazione a Novara di un importante centro di ricerca (che assumerà più tardi il nome di “Donegani”). Nel 1936 Fauser sarà uno dei promotori dell’Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (ANIC), con capitale misto pubblico e privato. Prima della Montecatini anche altre grandi industrie avevano attrezzato ampi laboratori di ricerca. Nel 1917 la Società Italiana Pirelli aveva affidata la direzione del suo laboratorio di ricerche fisiche e chimico-fisiche a Bruni, mentre nel ’18 Parravano era già impegnato con l’Istituto Scientifico Tecnico “E. Breda”. A partire da quegli stessi anni Cambi sviluppava un intenso rapporto con l’industria fondando su basi scientifiche la complessa metallurgia elettrochimica dello zinco e del piombo (S. Dalmazzo di Tenda, 1921, ed altri impianti nel ’26, ’34 e ’53); più tardi Cambi avvierà l’elettrometallurgia del cadmio (Monteponi, 1930 e Porto Marghera, 1937).
L’attività innovativa di Cambi si svolse anche nel contesto accademico. Fra il ’22 e il ’24 organizzò la Laurea in Chimica industriale presso l’Università di Milano, fondando l’Istituto omonimo. Sono anni intensi: nel 1920 Levi viene chiamato a Bologna sulla cattedra di chimica applicata della scuola per ingegneri; in quella Università fonda nel ’22 la Scuola superiore di chimica industriale, presso la quale nel ’26 il Ministero dell’Economia Nazionale istituisce una speciale “Sezione di studi sui combustibili”. Nel ’27 Levi viene chiamato a Milano sulla cattedra di chimica industriale del Politecnico, lasciata vacante dalla morte di Molinari. Levi vi trasferisce anche la Sezione Combustibili, che nel ’40 (quando Levi era al bando) diverrà “Stazione sperimentale per i combustibili”.
Mentre l’istituzione della Sezione combustibili rientra ancora in un tipo di intervento dello Stato che diremmo ‘specialistico’, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (1923) rappresenta una forma nuova di interazione fra la comunità scientifica nel suo complesso e le finalità economico-sociali dello Stato. Nel ’27 Parravano ne assume la vicepresidenza (presidente era Marconi) e la direzione del settore chimico. Nel ’33 viene l’Istituto per la Ricostruzione Industriale; l’elettrochimico Francesco Giordani (1896-1961) ne è presidente dal ’36 al ’43, e con questo ruolo viene consolidata l’influenza della cultura chimica sulla società italiana. Nel ’34, infine, in seguito alla forte iniziativa di Domenico Marotta (1886-1974) vengono fusi in unico organismo il Laboratorio chimico del Ministero degli Interni, e quelli di Batteriologia e di Malariologia, nonché l’Ufficio per le sostanze radioattive (nato nel ’23). Nasceva così l’Istituto di Sanità Pubblica, divenuto Istituto Superiore di Sanità al momento dell’inaugurazione della grande sede di viale della Regina a Roma. In questo Istituto, prima e dopo la guerra mondiale fu condotta della ricerca d’avanguardia; fra quelle precedenti il conflitto mondiale furono memorabili quelle di fisica nucleare guidate dal gruppo di Enrico Fermi; dopo lo scioglimento di questo gruppo le indagini di radiochimica continuarono con l’opera di Oscar D’Agostino (1901-1975). Dopo la guerra l’Istituto svolse un ruolo di primo piano a livello mondiale nella ricerca sugli antibiotici e su composti naturali come i curari.
Come si può capire la chimica, anche e soprattutto accademica, era strettamente connessa all’industria ed al regime. Ben altri furono quindi le disponibilità di persone, di mezzi e di finanziamenti rispetto ad altri settori della ricerca scientifica, anche perché la chimica era vista, a ragione, come la scienza più indicata a risolvere i problemi che poneva l’autarchia.
Ma, nonostante i successi della chimica ora visti, vi era un problema grave, che era lo stesso e discendeva in parte da quello visto per la fisica. Fu Luigi Rolla a denunciare la cosa nel Congresso della SIPS del 1939, quello cioè del centenario della Società. Rolla disse che nei cento anni di storia che ricorrevano, a parte i contributi di Stanislao Cannizzaro, agli imponenti risultati della chimica applicata in genere, non corrispondono quelli della chimica teorica. Ed anche qui, senza la parte teorica si ha respiro corto tanto è vero che oltre certi livelli non si riuscì ad andare ed occorrerà aspettare in secondo dopoguerra per riuscire a coprire l’handicap con, ormai, non solo l’Europa ma anche gli Stati Uniti.
6 – IL FASCISMO AL POTERE
Prima di proseguire è utile dare uno sguardo a qualche problematica che si pose come conseguenza della presa del potere da parte del Fascismo.
Il primo governo Mussolini (1923) si mosse in modo che può definirsi “liberista”: lo Stato non interveniva nelle vicende economiche se non per dare una mano alla libera iniziativa. Le assicurazioni sulla vita e i telefoni vennero privatizzati; le risorse idriche, la produzione e la distribuzione dell’energia elettrica vennero lasciate ai privati; fu abolita la nominatività dei titoli azionari; la Commissione parlamentare d’inchiesta sui profitti bellici vide resi vani i suoi lunghi lavori.
Il ceto medio liberista venne lusingato e accontentato nella sua più alta aspirazione relativa alla “sicurezza” del suo status.
Nacquero così le carriere garantite: lo status giuridico dei magistrati, il rafforzamento del personale ausiliario dell’esercito, la creazione dei gradi intermedi nella pubblica amministrazione …
Le retribuzioni di quella che Sergio Romano definisce la “palude elettorale fascista” (poi diventata palude elettorale DC ed ora PdL) vennero gonfiate a scapito del salario degli operai che, fra l’altro, videro passare la loro giornata lavorativa da 7,5 ad 8,5 ore.
L’inflazione galoppava e, mentre i salari venivano mantenuti fissi da agrari e industriali, lo Stato sosteneva questa politica. La grande massa di disoccupati che il dopoguerra aveva creato (ristrutturazione delle industrie belliche) contribuì a questo stato di cose: da una parte offriva manodopera di ricambio disperata a basso costo, dall’altra incrementava le fila dei “tutori dell’ordine” (la Milizia volontaria per la Sicurezza nazionale arrivò a 250000 unità, 250000 “impiegati” poi addirittura passati nei ruoli dello Stato).
Tutto ciò porterà a successi clamorosi del primo Mussolini: la crescita economica dell’Italia fu seconda solo a quella del Giappone; il deficit della bilancia dei pagamenti venne ridotto grazie anche alla svalutazione della lira. Nel 1926, dopo le “Leggi speciali”, si ebbe una svolta nella politica economica del governo: iniziò la difesa della lira con la conseguente forte diminuzione delle esportazioni. Per pareggiare il bilancio si dette il via alla “battaglia del grano”; i dazi vennero aumentati a dismisura; vennero contingentate o vietate alcune importazioni; la lira venne rivalutata per arrivare a quel cambio di prestigio che serviva al governo (92,46 lire per una sterlina, la famosa “quota 90”); la circolazione di moneta si ridusse; le banche cominciarono a trovarsi in difficoltà; per realizzare liquido i finanzieri iniziarono a vendere in borsa; la borsa precipitò in pochi mesi da 146 a 78; crollarono sul mercato i prezzi di svariati prodotti; scese l’indice della produzione industriale e agricola; i disoccupati aumentarono in modo vertiginoso.
La crisi Usa del 1929 ebbe effetti gravissimi sull’Italia (che pure, nonostante quanto sostenuto più sopra, era in fase di lieve ripresa); la borsa e la banca crollarono trascinando con sé nel disastro molte industrie, anche di grandi dimensioni.
Lo Stato intervenne per salvare le banche e, nel far questo, s’impadronì di molte di esse e di molte industrie collegate. L’IRI nacque (1933) proprio come ente che doveva organizzare e gestire le imprese di cui lo Stato si era impadronito. L’altra linea di politica economica del governo fu quella che tendeva a favorire in tutti i modi la creazione di grandi monopoli.
Effetti di questa politica furono: una possente concentrazione di aziende elettriche (Edison, Sade, Volta …); una grande industria meccanica (Fiat); importanti aziende chimiche (Montecatini, Snia-Viscosa, Pirelli); un monopolio del cemento (Italcementi).
La guerra d’Etiopia (1936) produsse un ulteriore, imponente, travaso di capitali verso la grande industria, particolarmente verso quella meccanica. A questo punto le “sanzioni” e la conseguente “autarchia” rovinarono completamente l’economia italiana. L’industria, in mancanza di concorrenza, produceva merci sempre più scadenti; conseguenza di ciò è che questa industria aumentava a dismisura i suoi profitti (crebbe clamorosamente il monopolio elettrico; si sviluppò molto l’industria chimica con la produzione di azoto, coloranti, medicinali, soda, cloro, esplosivi e iniziò la produzione di materie plastiche e di fibre sintetiche, come raion, fiocco e lanital). Le esportazioni si ridussero del 64%. L’inflazione galoppava. L’Italia era tagliata fuori dai mercati mondiali (dal 1927 al 1939 le riserve auree scesero del 74%).
Unici effetti “benefici” dell’autarchia furono probabilmente il potenziamento dell’industria motociclistica italiana e della produzione di macchine utensili. A fronte di ciò, come afferma R. Romeo, “L’eliminazione di ogni concorrenza anche sul mercato interno costituiva a vantaggio degli industriali una serie di posizioni monopolistiche rispetto al consumatore, e in pari tempo agiva da freno sul progresso tecnico permettendo, con gli alti prezzi, la sopravvivenza di una serie di impianti poco efficienti, garantiti dall’assegnazione di determinate quote della domanda”.
Nel 1938 si realizzò un nuovo cambiamento di rotta: iniziò una strana campagna contro la borghesia e lo scellerato attacco contro gli ebrei. A partire da questo momento i liberali e gli ebrei, fino ad allora sostenitori entusiasti, non gradirono più il fascismo.
In definitiva, alcune caratteristiche di fondo del fascismo italiano si possono così riassumere:
– sacrifici della classe operaia (i salari nel 1930 risultano dimezzati rispetto al 1921, sono i più bassi d’Europa dopo quelli spagnoli);
– estendersi del ceto medio (grandi industrie ed enti pubblici);
– creazione di grandi monopoli;
– esodo dalle campagne;
– disoccupazione ed emigrazione;
– esilio per molti ingegni.
Aspetti d’interesse sono:
– la creazione dell’IRI ebbe come effetto che era lo Stato a dirigere l’economia (l’Italia era seconda solo all’Urss per la concentrazione dell’industria di Stato!);
– restavano comunque aspetti contraddittori. Ad esempio, l’IRI diveniva proprietaria di un’ampia quota dell’industria elettrica, ma la gestiva con criteri privatistici allo stesso modo della rimanente industria elettrica privata (Edison, Sade, Volta) nella politica degli alti prezzi e della diversità di essi con grande penalizzazione del meridione. In questo modo, mentre la grande industria che si autoproduceva energia elettrica non veniva intaccata dalla politica degli alti prezzi, veniva portata al disastro la piccola e media industria;
– la “battaglia del grano”, oltre a quanto si è già detto, ebbe ulteriori effetti negativi nel settore agricolo-alimentare. E’ vero che l’importazione di grano si ridusse del 75% (con l’industria chimica che si arricchiva attraverso i fertilizzanti) ma è altrettanto vero che si tentava di produrre grano a qualsiasi prezzo, a scapito cioè di altre coltivazioni – ortofrutticoli e olive – e dell’allevamento.
Dice S. Romano: “Successi ancora più cospicui realizzò il fascismo proiettando nel mondo, con sapiente regia, l’immagine di un paese moderno, dinamico, sportivo. [Le grandi imprese] erano per l’Italia [e per la grande massa di emigranti che pur fornivano 5 miliardi di lire di rimesse annue per finanziare, fra l’altro, la “battaglia demografica”] altrettante battaglie vinte. ‘Ricordatevi – aveva detto Mussolini a un gruppo di sportivi il 28 ottobre 1934 – che , quando vi misurate in terra straniera, è ai vostri muscoli e soprattutto alle vostre virtù morali che sono affidati l’onore e il prestigio sportivi della nazione’ “. E gran parte dello spirito frustrato degli italiani esultava a queste parole, così come esultava all’annuncio di un nuovo record, di un nuovo primato, di una nuova vittoria in un qualche campionato.
7 – FASCISMO, SCIENZA, INDUSTRIA
L’atteggiamento del fascismo nei confronti della scienza può essere riassunto nell’enfasi che venne posta su tutto ciò che di applicativo la scienza stessa era in grado di fornire, su tutto ciò che avesse il senso dell’uso pratico e quasi quotidiano. Il livello più elevato di questa concezione lo sì può ritrovare in un discorso che Giovanni Gentile, allora ministro dell’educazione, pronunciò nel 1923 al Convegno annuale della Società italiana per il progresso delle scienze (SIPS), dal significativo titolo “La moralità della scienza“. La scienza, secondo Gentile, ha un valore morale in quanto è un prodotto dell’uomo. La responsabilità della ricerca scientifica è tutta dell’uomo, che avrà fatto il proprio dovere se si sarà reso utile alla patria. Quindi scienza per i bisogni politici ed economici della patria.
Più in generale, i filosofi idealisti italiani, ai quali ho accennato, tentavano (riuscendovi) di accreditare l’idea del primato della filosofia sulla scienza. Ciò che elaboravano gli scienziati era solo una riscoperta di idee già abbondantemente discusse e digerite nell’ambito della filosofia. Questo giudizio, evidentemente, era relativo a ciò che questi filosofi erano in grado di capire dei recenti sviluppi della scienza in generale e della fisica in particolare. A proposito della relatività e dei quanti non erano in grado di opinare, e invano chiedevano a Gentile e Croce che assumessero una posizione sull’argomento. Probabilmente, l’incapacità di questi filosofi di muoversi sul terreno epistemologico(3) contribuì, in cascata, a due fatti importanti: a) il fascismo, contrariamente al nazismo (relatività sviluppata da un ebreo: più in generale scienza ebraica e/o scienza degenerata) e al bolscevismo (quanti sviluppati in occidente; biologia sviluppata in occidente: più in generale scienza occidentale) non assunse chiusure ideologiche contro la nuova fisica; b) Fermi e il suo gruppo, certamente non aiutati – soprattutto economicamente – altrettanto certamente (pur muovendosi nell’ambito della nuova fisica) non vennero ostacolati.
In ogni caso la richiesta di una scienza pratica, se da una parte comportava l’esclusione dai finanziamenti di gruppi “teorici” (il gruppo Fermi e tutti quelli che iniziarono a sorgere come diretta o indiretta filiazione di Fermi furono tagliati fuori da tutta la messe di risultati connessi con la scoperta, della radioattività, per l’impossibilità di comprarsi materiali radioattivi) dall’altra non garantiva di per sé i finanziamenti a supposti gruppi “sperimentali”. Furono necessarie molte pressioni e interventi diretti di gruppi industriali “illuminati” perché all’espansione economica del primo fascismo si accompagnasse una crescita, almeno, della scienza applicata. A favore quantomeno del riordino e dell’accrescimento di dotazione dei laboratori scientifici universitari intervenne lo stesso Mussolini in occasione del Convegno della SIPS del 1926.
Il discorso di Mussolini un qualche effetto lo ebbe: il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), creato nel 1923, che aveva come compito istituzionale quello di farsi promotore e coordinatore di ricerche nell’ambito anche di propri laboratori e che non era mai stato messo in grado di funzionare, nel 1927 fu riformato in modo da disporre sia di fondi che di una struttura organizzativa che gli permettessero di operare (anche se con mezzi di gran lunga inferiori ad analoghe istituzioni di altri Paesi). Fu il matematico Volterra a pensare a uno statuto di CNR già nel 1919. Alla presidenza di questo ente andò chi meglio riassumeva l’ideale dello scienziato fascista (una gran parte applicativa, nessuna elaborazione teorica, prestigio internazionale, successo imprenditoriale, politicamente inesistente): Guglielmo Marconi, uno dei rappresentanti italiani alle conferenze per la pace che seguirono la prima guerra mondiale e che si era iscritto al Partito Nazionale Fascista (PNF) nel 1923. Con il Fascismo, Marconi ebbe rapporti molto stretti e non si sa bene chi di più dovette all’altro (nel 1935 fu creata, appositamente per lui, la cattedra di Onde Elettromagnetiche presso la Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali dell’Università di Roma).
Il neopresidente aveva però troppi problemi personali per potersi dedicare appieno alla funzione manageriale richiesta. Non “spinse” come avrebbe dovuto e potuto per avere maggiori finanziamenti da parte dello Stato e dell’industria (solo la Edison e la Montecatini si mostrarono lungimiranti finanziando il CNR). È interessante osservare che intanto, sulla scia di quanto era già avvenuto in vari Paesi (soprattutto in Germania), ci si andava convincendo del corto respiro che avevano le iniziative di scienza immediatamente applicata. Da varie parti (chimici e matematici soprattutto, ma anche alcuni ambienti industriali) si cominciò a osservare che una “scienza pratica”, non alimentata da attività teorica è destinata a scomparire(4).
Il CNR, comunque, dipendeva completamente dall’università per laboratori e strutture. Solo a partire dai primi anni Trenta poté iniziare a gestire in proprio l’Istituto nazionale di ottica e l’Istituto per le applicazioni del calcolo. Qualcosa quindi si muoveva. La crisi economica dei primi anni Trenta rallentò i processi che si erano avviati, e si dovette aspettare la politica autarchica che seguì alle sanzioni internazionali perché di nuovo si cominciasse a puntare sulla scienza per risolvere i problemi produttivi. Fu questo il momento di molte autocritiche sui ritardi che la retorica degli anni precedenti aveva accumulato; ma fu anche il momento in cui si accentuò la richiesta di scienza applicata che sfociò in molti casi in tante iniziative sbagliate, contraddittorie, velleitarie, quando non erano ridicole e truffaldine (i casi del “lanital” e dell’estrazione di ferro dalle sabbie di Ladispoli possono essere due esempi in questo senso). Su questo comunque dirò di più nel paragrafo seguente.
Nel 1937, a seguito di svariate istanze, il CNR fu di nuovo riformato. Dopo la morte di Marconi fu chiamato alla sua presidenza – fatto significativo dell’uso che di questo ente si voleva fare – il generale Badoglio. Aumentarono i finanziamenti: l’ente tu dotato di un edificio a fianco dell’ università; altri istituti e laboratori entrarono sotto la sua diretta gestione: l’Istituto elettrotecnico Galileo Ferraris di Torino, l’Istituto di Elettroacustica Orso Mario Corbino di Roma, l’Istituto di ricerche biologiche di Rodi.
Ma la guerra era alle porte e, intanto, venivano promulgate le leggi razziali. Quella struttura, che cosi faticosamente stava nascendo, in breve tempo si sarebbe vanificata.
Un cenno a questo punto va fatto ai rapporti tra ricerca tecnologica, produzione industriale e autarchia. Ed è anche molto semplice capire che la gran parte dell’industria italiana puntava unicamente al più alto profitto da conseguirsi nel modo più facile. In epoca precedente la prima guerra mondiale l’industria produceva essenzialmente copiando brevetti stranieri (massimo profitto con il minimo sforzo, con la conseguenza che la ricerca fondamentale la facevano gli altri). Si ripete ora la stessa cosa: in mancanza di una qualsiasi concorrenza i processi produttivi non vengono in alcun modo migliorati, si vivacchia con prodotti scadenti e con laboratori di ricerca che non aggiornano i loro strumenti. Anche qui occorre però dire che vi furono delle eccezioni in settori “strategici”, quello dei concimi e quello dei combustibili.
Nel primo alcuni importanti risultati furono conseguiti da Palazzo (concimi fosfatici), da Fauser, Casale (concimi azotati) e Blanc (concimi potassici); nel secondo settore, ritenuto molto importante se già nel 1926 era stata creata l’Agip, Natta, nel quadro dei progetti di sostituzione della benzina con alcool etilico e metilico, realizzò un processo in cui l’idrogeno veniva prodotto per via elettrolitica (l’Italia disponeva di energia elettrica) anziché dal carbone come comunemente si faceva. E non può tacersi il fatto che dietro ogni ricerca di un qualche calibro vi era sempre la Montecatini, che riuscì in questo modo a espandersi enormemente.
Situazione contraddittoria, dunque. Da una parte alcuni processi e integrazioni erano avviati, dall’altra il provincialismo e la rozzezza lasciavano le iniziative isolate tra loro, senza strutture né coordinamento. A questo proposito è interessante riportare (R. Maiocchi) le conclusioni del non sospetto 1° Convegno per lo sviluppo dell’autarchia industriale (1938).
Le cose non funzionavano a seguito di:
– debolezza delle strutture;
– scarso coordinamento;
– carenza di ricercatori;
– squilibrio esistente tra poche grandi industrie (nelle quali si fa sia la ricerca in proprio che quella coordinata con i laboratori statali) e la stragrande maggioranza delle industrie medie e piccole (che non sanno neppure cos’è la ricerca);
– livello tecnologico arretratissimo di quasi la totalità dell’industria italiana;
– i successi ottenuti sono dovuti più all’iniziativa di individui isolati che non a un piano preordinato.
In definitiva pare si possa concludere, con R. Maiocchi, che: “Il fascismo non seppe sfruttare la disponibilità all’impegno, indubbiamente presente in gruppi di scienziati e tecnici, per l’incapacità di pianificare e coordinare un’attività di ampio respiro, per il modo affrettato, rozzo e dilettantesco in cui venne affrontata la costruzione di una “società imperiale”: carenze, queste, che crearono una sostanziale sfasatura tra ricerca e bisogni autarchici, senza che ciò fosse dovuto a resistenze o boicottaggio da parte dei ricercatori i quali, anzi, si lamentarono poi di non essere stati ascoltati”.
8 – SCIENZA E INDUSTRIA PER L’AUTARCHIA
Come eredità dell’impegno degli scienziati italiani nella Prima Guerra Mondiale, il matematico Vito Volterra riuscì a fondare un ente morale con legami ad altri enti europei consimili, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), che nelle ipotesi iniziali avrebbe dovuto coordinare ogni ricerca scientifica in Italia. Il CNR nasceva nel novembre del 1923 sull’onda di una realizzazione privata precedente dello stesso Volterra, l’Ufficio Invenzioni e Ricerche. Il nuovo ente ebbe una collocazione vicina all’Accademia dei Lincei ed una qualche dipendenza dal Ministero dell’Educazione con finanziamenti molto esigui. I primi anni di vita dell’ente coincisero con le prime imprese del fascismo e Volterra, presidente del CNR, era un personaggio caratterizzato da netto e solido antifascismo con ricadute negative da un regime che sapeva punire i suoi avversari. In definitiva il CNR nasceva strangolato e nei suoi primi 4 anni di vita non riuscì a far altro che qualche censimento degli istituti di ricerca presenti in Italia. Nel 1927, con il fascismo già saldamente al potere (rivendicazione da parte di Mussolini dell’assassinio di Matteotti e squadracce all’opera in tutta Italia), l’ente fu riorganizzato. Allo scadere della presidenza Volterra non gli fu rinnovato il mandato che fu invece passato a Guglielmo Marconi. Il CNR fu sganciato dall’Accademia dei Lincei e collegato all’Accademia d’Italia con il compito di consulenza al Duce mediante il coordinamento delle attività nazionali nei vari rami della scienza e delle sue applicazioni anche nell’interesse della economia generale e con quello di organo permanente consultivo e di informazione per il Ministero dell’Educazione.
La storia dell’ente dai suoi inizi fino al 1945 è ricchissima di episodi di vario genere. Dentro questa storia vi sono interessi molto grandi da parte di industrie italiane, di spiriti truffaldini, di persone che seriamente cercavano di indirizzare la ricerca del nostro Paese, anche se a fini non condivisibili, di interessi e sfiducia dei militari, … insomma è uno spaccato di quella che era la società italiana e, per molti versi di come anche oggi vanno le cose in Italia. Non farò una tale storia anche perché il lavoro dell’intersezione tra CNR, scienziati e fascismo è stata fatta egregiamente da Roberto Maiocchi (2003). Mi limiterò, seguendo la traccia di tale lavoro, a riportare solo gli episodi salienti per la comprensione della complessa dialettica che si originò.
Per comprendere la natura dell’ente è utile riportare i nomi e le funzioni delle persone che dovevano dirigerlo a fianco di Marconi: Giovanni Magrini (ex funzionario del Comitato talassografico e fedele mussoliniano), Bonaldo Stringher (governatore della Banca d’Italia), Amedeo Giannini (diplomatico in rappresentanza del Ministero degli Esteri, per il ruolo internazionale dell’ente), Ugo Frascherelli (direttore generale del Ministero dell’Educazione), Nicola Vacchelli (generale che dirigeva l’Istituto Geografico Militare di Firenze), Nicola Parravano(chimico, unico rappresentante laureato dell’università al quale poco dopo fu affiancato un altro professore universitario ma proiettato più verso l’industria chimica, Gian Alberto Blanc).
I primi tempi furono di completa stasi dovuta all’assenza di indirizzi e alla cronica mancanza di finanziamenti, anche a seguito della profonda crisi finanziaria nella quale l’Italia del dopoguerra continuava a dibattersi. Marconi pose il problema delle radiocomunicazioni e riuscì con fondi provenienti dal di fuori del CNR a realizzare il Centro Radioelettrico Sperimentale di Torre Chiaruccia. Si pose il problema di realizzare vetri ottici per strumenti di precisione di grande interesse anche militare. Più in generale prevalse l’indirizzo del sostegno all’industria nazionale in un momento in cui il forte deficit della bilancia ei pagamenti concentrava l’attenzione sulla principale voce di uscita, quella per l’acquisto dei carburanti. La Francia era il riferimento perché in quel Paese vi erano degli studi avanzati della trazione a gassogeno, un dispositivo in grado di produrre gas a partire da una massa solida, generalmente una sostanza (biomassa)derivata da produzione agricola e quindi proprio ciò che faceva al caso dell’Italia, Paese quasi completamente agricolo. Nel marzo del 1930, su impulso di Parravano, fu deciso che il problema del gassogeno era di grande interesse, anche per disporre proprio dove più occorreva, nelle arretrate campagne, di un sistema per la trazione di macchine, e meritava di essere studiato. Il comitato del CNR che si occupava di agricoltura fu sottoposto a molte e variegate sollecitazioni per estrarre tutto il possibile dai prodotti agricoli. Scriveva Parravano, che pure era legato all’industria metallurgica, che noi dobbiamo concepire il mondo un poco diversamente [dai Paesi Nordici] e ricorrere con più larghezza e per compiti di maggior rilievo alle officine chimiche del buon Dio, officine che non hanno capriate di fero rugginoso, ove non v’è atmosfera fumosa e viziata ma ove l’operaio, pur più povero, canta al sole la sua canzone, che è quasi sempre d’more e di gioia. E pur essendo agli inizi degli anni Trenta scopriamo che la retorica fascista avanzava con la falsificazione della dura realtà di miseria, lacrime e sangue che gli operai hanno sempre pagato per maggior gloria, non già di Dio, ma dei padroni. Comunque questo spirito rurale era largamente diffuso, anche tra scienziati di varia estrazione.
Altre iniziative furono del CNR nei primi anni Trenta; tutte indirizzate, con pochissimi fondi, a questioni d’interesse accademico sollevate da svariati professori universitari che sollecitavano attenzione per loro ricerche e per lavori teoretici. I finanziamenti erano a pioggia e si poteva registrare un 50% dei fondi a disposizione per i più svariati progetti di ricerca e l’altro 50% per il mantenimento dell’ente (stipendi, missioni, segreteria, …). Il direttorio, essendo composto in prevalenza da non scienziati, non bloccò alcuna ricerca cosa che semmai fece il Ministero dell’Educazione ridisegnando le dotazioni di varie facoltà.
I primi anni Trenta furono segnati da un evento drammatico per un’economia che tentava di riprendersi, la crisi economica mondiale. Vi furono fallimenti di banche che comportarono nazionalizzazioni e creazioni di nuovi istituti. La reazione a varie manovre economiche internazionali fu di chiudersi nel protezionismo e quindi a rinnovare l’attenzione alle produzioni nazionali con un rilancio del mercato interno. Per quel che ci interessa alcune delle proposte del passato vennero ora riprese con l’attenzione della necessità economica. C ome riassume Maiocchi (2003):
Ripresero con una certa lena gli studi sull’ alcool carburante, sullo sfruttamento delle rocce asfaltiche e bituminose, sulla utilizzazione dei combustibili nazionali secondo modalità che comprendevano le recenti tecniche di idrogenazione, sull’impiego del gassogeno per autotrazione, cominciò a esser preso sul serio il petrolio presente nel sottosuolo italiano, il CNR avviò una rassegna dei combustibili nazionali, anche la cellulosa da piante nazionali, annuali o meno, ritornò a essere presa in considerazione, così come ricevettero attenzioni le risorse delle nostre colonie, l’impiego come lubrificante dell’olio di ricino o dell’olio di oliva, la possibilità di sfruttare i nostri minerali metalliferi poveri o le nostre piante aromatiche e medicinali. Naturalmente proseguirono ancora le ricerche inerenti produzioni tecnologicamente molto avanzate, come quelle di Giulio Natta e dei suoi collaboratori sulle sintesi catalitiche degli alcooli e dei loro derivati o quelle di Livio Cambi e della sua scuola sui metalli non ferrosi ma anche queste furono vissute, o comunque presentate come imprese ad alto significato patriottico e contribuirono anch’esse alla costruzione di un clima culturale sempre vivacemente proteso al raggiungimento dell’autonomia della Nazione.
Era il clima adatto per il rafforzamento del CNR e di azioni da portare avanti assieme agli industriali. Furono create le più svariate commissioni per studiare i più svariati temi ed il CNR divenne consulente del governo per almeno una questione, l’alcool carburante (quale miscuglio di alcool etilico con benzina avrebbe funzionato meglio). Il CNR, sotto la spinta di Parravano, attivò il Comitato per i combustibili per fare ricerche in laboratori militari, dell’ACI e della facoltà di Ingegneria di Roma. Dopo studi accurati venne stabilito che la percentuale migliore era del 5%, anche perché era quella che corrispondeva alla produzione italiana di alcool. Il governo, sensibile ad ogni suggerimento degli scienziati, emanò un decreto in cui si faceva obbligo di miscelare al 20%. Ho citato questo episodio che sembra marginale per mostrare come vi sia sempre in Italia la sottovalutazione della ricerca ed il gioco con i numeri.
A lato di episodi come questi e di ricerche che, pur proposte, non furono mai iniziate, vi furono anche dei successi di grande portata. Uno di tali successi fu la realizzazione da parte del matematico Mauro Picone dell’Istituto Nazionale per le Applicazioni del Calcolo che fu una sorta di base su cui si fondarono gran parte delle ricerche future del CNR e che fu da sostegno per ogni iniziativa sia pubblica che privata. Riguardo ai comitati del CNR, quello che ebbe maggior peso fu il Comitato per le materie prime, creato nel 1932 ed affidato a Blanc, che fece una sorta di catalogo delle disponibilità nazionali, dei nostri bisogni, delle capacità di produzione e di quelle di surrogazione. Era un indispensabile punto di partenza per capire cosa fare e cosa si poteva fare. Blanc cercò aiuto da coloro che potevano avere le prime informazioni, come l’ISTAT ed il Comitato di Mobilitazione Civile (ente diretto dal generale Dallolio che aveva lo scopo di mobilitare il sistema produttivo del Paese in caso di guerra), ma la collaborazione fu scarsa fino al 1933 quando la crisi aveva raggiunto i suoi momenti più drammatici ed il governo, dopo aver creato l’IRI che raccoglieva la miriade di fabbriche che andavano fallendo e che si proponeva come ente di Stato nella produzione industriale e più in generale nella gestione dell’economia del Paese, portò a compimento la realizzazione del corporativismo come uscita di salvezza dal capitalismo, che fu dichiarato decaduto da Mussolini il 14 novembre 1933. In tale clima il CNR si poneva come un ente in grado di risolvere importanti questioni nazionali e fu allora che lo stesso Presidente, Marconi, pose come fondamentale la questione della materie prime. Iniziarono così ad essere prodotte una sequela di relazioni che, in gran parte, rimasero come tali ma, fatto più importante, si progettò la realizzazione di 3 laboratori nazionali del CNR. Ma fu lo stesso Mussolini a bloccare il tutto perché non vi erano i fondi e ad aprire la strada a possibili ed auspicabili, ma mai arrivati, finanziamenti dell’industria privata.
La caduta per legge del capitalismo e la nascita per legge delle corporazioni indicò la strada da seguire che iniziò con una guerra di aggressione coloniale, alla mobilitazione per la quale furono naturalmente chiamati anche gli scienziati ed il CNR. Giovanni Magrini aderì subito per il CNR e propose la creazione del Comitato per le applicazioni della scienza alla difesa nazionale. Questo Comitato fu bocciato ma Mussolini pensò che qualche cosa si sarebbe potuto ricavare dalla scienza e creò nel 1934 il Comitato di coordinamento tra CNR e militari, dando qualche finanziamento in più al CNR. Ma il Comitato sparì nel nulla dopo la sua prima riunione per l’incompatibilità tra scienziati e militari. E, più in generale, dalle euforie iniziali si era passati ad una situazione in cui non si capiva più il ruolo del CNR in uno Stato corporativo.
Nel 1935, con la crisi economica ancora al suo apice, si dette il via all’aggressione dell’Etiopia (Abissinia)(5). Come conseguenza immediata la Società delle Nazioni impose delle sanzioni all’Italia con il blocco economico, con il divieto cioè per gli aderenti alla Società di esportare in Italia prodotti strategici tra i quali, appunto, le materie prime. Il blocco non fu comunque rigido perché non tutti i Paesi con cui l’Italia era in relazioni commerciali aderivano alla Società delle Nazioni. L’evento fu comunque utilizzato dal Regime come motivo di propaganda (inique sanzioni) che, in ogni caso, comportava di aggiungere a quanto la crisi internazionale richiedeva di produzione nazionale a quanto non arrivava più come merce dall’estero, particolarmente per ciò di cui mi occupo, petrolio e carbone. Fu così che sorse l’autarchia, un programma di autosufficienza economica senza dipendenze con l’estero che, annunciata da Mussolini il 31 agosto del 1935 (l’aggressione all’Etiopia seguì il 2 ottobre), si definirà con precisione, come piano di misure coordinate, soltanto nel 1937. Tale politica, per anticipare qualcosa, si risolse in gran parte in una serie di improvvisazioni dettate più dalle esigenze del giorno per giorno che non da una qualche programmazione. All’autarchia furono chiamati a collaborare gli scienziati. Era davvero una follia pensare di sistemare la crisi economica interna, regolare il debito con l’estero ed affrontare una guerra, tutto senza materie prime da utilizzare nella misura necessaria. Dallolio diceva che avevamo tutto meno i combustibili ma mentiva. I problemi erano enormi ed il CNR fu chiamato in causa con una lettera del marzo 1935 dello stesso Mussolini a Marconi:
È assolutamente necessario che il CNR polarizzi e concentri i suoi sforzi, sui seguenti problemi, allo scopo di trovare per essi, una soluzione nazionale e industriale al tempo stesso (cioè non di semplice laboratorio). A) problema del carburante nazionale (alcool, roccie e scisti, gassogeni, ecc.). B) problema del tessuto nazionale. C) problema della cellulosa nazionale. D) problema della utilizzazione dei combustibili solidi nazionali (carboni, ligniti, etc.). Per taluni dei qui elencati problemi esistono studi, esperienze e anche applicazioni industriali (in scala iniziale). E’ tempo di dare al Governo le basi per agire su vasta scala.
E prontamente Marconi rispondeva:
Eccellenza. In conformità degli ordini impartiti dall’E.V il CNR ha avviato gli studi e le indagini per la soluzione nazionale ed industriale dei problemi della cellulosa e della canapa, come tessuto nazionale. Su tali problemi mi pregio accludere due relazioni preliminari. Quanto agli altri problemi segnalati dall’E.V come meritevoli di immediate indagini mi riservo di inviare quanto prima dettagliate relazioni sugli studi compiuti [tuttavia alla lettera risultano allegate anche una relazione sull’alcool etilico e una sui combustibili solidi nazionali]. Aggiungo che qualche altro problema è apparso necessario mettere allo studio, ma su di esso e sui lavori all’uopo compiuti mi riservo di riferire egualmente al più presto. […]
Mi consenta V.E. di farle presente che l’opera del Consiglio è paralizzata dalla mancanza dei mezzi che occorrerebbero soprattutto per impiantare i laboratori per la chimica, la fisica e la biologia; finché non si potranno impiantare tali laboratori il Consiglio non potrà rendere quel che potrebbe rendere ed ogni anno perduto implica il differimento di indagini e forse della soluzione di problemi fondamentali per la vita della Nazione.
Il problema più urgente, era chiarissimo, era quello della materie prime e, tra esse, dei combustibili.
Si iniziò a reperire dati e su questo si attivò il Comitato diretto da Blanc il quale però affermò che tali dati erano stati forniti dalle industrie e non si conosceva la loro attendibilità perché erano stati raccolti mediante l’invio e la raccolta di questionari. Si poteva, come già fatto in passato ricorrere al Comitato dell’esercito diretto da Dallolio ma si venne a sapere che le informazioni in possesso di tale Comitato erano segrete. Fu quindi presentata a Mussolini una relazione autodefinita parziale. Dopodiché per circa un anno, fino agli inizi del 1936 quando erano state decise le inique sanzioni(6), tutto tacque. Quanto qui riassunto serve a capire il modo cialtronesco di operare che, unito alla mancanza di obiettivi seri e di collegamenti, rendeva inutile ogni sforzo.
Questo modo di procedere riguardò quasi tutti i Comitati: si presentarono relazioni (come quella elettrotecnica che aveva studiato la possibilità di sostituire il rame con l’alluminio e quella di costruzioni meccaniche che aveva studiato motori per l’uso di carburanti succedanei sia solidi che liquidi che gassosi) che poi qualcuno avrebbe, forse, letto.
I problemi italiani si possono capire dando un’occhiata ad una tabella che fornisce dati sulle importazioni italiane (da Maiocchi 2003):
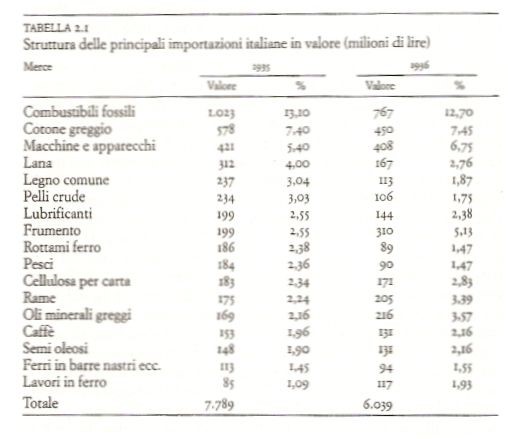
E’ chiaro che i combustibili fossili erano la voce più pesante delle nostre importazioni: ogni anno si acquistavano all’estero circa 12 milioni di tonnellate di tali combustibili che si suddividevano per uso nel modo seguente: 3,5 milioni di tonnellate per le ferrovie, poco più di 2 milioni di tonnellate per la distillazione nelle officine del gas e nelle cokerie, 2 milioni nell’industria metallurgica, un milione e mezzo in prodotti per l’edilizia. La situazione del carbone estratto in Italia, comunque di bassa qualità, era la seguente:

Si può facilmente ricavare che la produzione nazionale rappresentava circa un decimo dei bisogni. Per arrivare, almeno a pensare (perché il raggiungimento dell’obiettivo di completa autonomia dall’estero appariva irrealizzabile) di avvicinarsi al fabbisogno si pensarono tutte le possibili soluzioni ma la più promettente sembrava quella dell’utilizzo più razionale delle ligniti attraverso la loro trasformazione in combustibili liquidi: produzione di benzina mediante idrogenazione e di gas attraverso la sintesi del metanolo con processi molto avanzati tecnologicamente. Si puntava insomma ai combustibili liquidi e non tanto per esigenze civili, quanto per le future esigenze dei militari che dovevano far volare aerei e muovere carri armati. In vari studi e relazioni sembrava che vi fosse ottimismo. Da una parte si sosteneva che i combustibili liquidi erano una esigenza primaria per la guerra e dall’altra si pensava di farvi fronte attraverso. l’alcool utilizzato come carburante, la già detta idrogenazione delle ligniti, l’uso dei greggi nazionali (riferimento al poco petrolio esistente in Albania), la valorizzazione dell’energia elettrica (in massima parte di origine idroelettrica), l’utilizzazione del gassogeno, dell’ammoniaca, del cloruro di calcio, dei gas compressi e, come lubrificante, dell’olio di ricino (grande amore fascista). Nel dare queste indicazioni di massima non si teneva però conto del fatto che, in caso di guerra, le necessità sarebbero aumentate. Tutte queste cose vennero pubblicizzate grandemente ma si trattava di acquisire le tecniche richieste dall’estero spostando un problema di impossibili rifornimenti ad altri. La scienza e la tecnica italiana restarono però estranee a queste cose e ci si può rendere conto di ciò attraverso l’assenza di pubblicazioni sulla letteratura tecnico-scientifica nostrana.
Il principale consumatore di carbone erano le ferrovie (3 milioni e mezzo di tonnellate per anno). Si pensò empiricamente di utilizzare il carbone nazionale per far andare le locomotive. L’alto tenore di zolfo del carbone italiano guastava le locomotive in circa un mese. Si passò a locomotive a gassogeno ma non si ebbero risultati di rilievo. Più importante fu l’elettrificazione della rete ferroviaria che, utilizzando energia elettrica da fonte idroelettrica, liberava del carbone per altri usi.
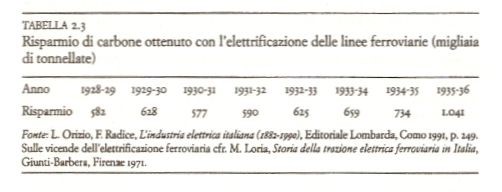
Altra utilizzatrice di carbone era l’industria del gas (2 milioni di tonnellate l’anno) che, attraverso distillazione ricavava vari prodotti di grande utilità strategica come gli oli leggeri, tra cui il benzolo (indispensabile per l’industria degli esplosivi e dei coloranti). Qualche risultato si ebbe anche utilizzando il benzolo come carburante. L’idea brillante fu quella di tassarlo per portarlo al costo della benzina con la conseguenza che aumentò la sua importazione perché l’industria preferiva comprarlo all’estero dove i costi erano molto più bassi. E ciò andò avanti finché non fu vietata l’importazione di benzolo.
Tra i combustibili fossili un ruolo importante era rivestito dal petrolio dal quale si ricavava principalmente benzina per autotrazione, visto che l’elettricità non era di origine termoelettrica. E quello dell’autotrazione era un settore vitale sia per il Paese che per i militari, come già accennato. Si trattava di trovare la possibilità di far muovere ogni mezzo a motore mediante dei succedanei della benzina (delle macchine realizzate a tal fine discuterò nel paragrafo seguente).
L’alcool, al quale ho già fatto cenno, rappresentava la più grande speranza anche se, anche qui, in modo superficiale e lontano da pratiche accordate con studi. Se le commissioni di studio indicavano un 5% di alcool etilico da mescolare con benzina per una resa ottimale accordata con la produzione nazionale, le autorità governative sparavano un 20%. Poiché il consumo di benzina si aggirava sulle 500 mila tonnellate annue, con la miscelazione richiesta dal governo sarebbero occorsi 1.200.000 ettanidri di alcool (un ettanidro corrisponde a 100 litri di alcool anidro, cioè puro, quindi a 100 gradi), a fronte di una produzione nazionale pari a meno di un terzo. L’alcool richiesto sarebbe stato prodotto dall’agricoltura e principalmente dalla barbabietola da zucchero. Ma come arrivare a triplicare il prodotto ? Le eccelse menti al governo ridussero del 60% il consumo della benzina aumentandone a dismisura il prezzo. Questo provvedimento, insieme ad un accordo con bieticoltori, zuccherieri e produttori di alcool che annusarono il grande affare), riuscì a far sì che la miscelazione di alcool in benzina arrivasse al 20% stabilito dal governo. La cosa durò fino alla fine delle sanzioni e subito dopo gli stabilimenti approntati furono abbandonati e si tornò allegramente a consumare benzina pura. Si ebbero anche attriti tra i produttori di alcool e barbabietole (diventati monopolio) e l’aeronautica che preferiva procedimenti diversi dalla barbabietola per produrre l’alcool (sintesi a partire dall’alcool metilico e/o cascami di altre produzioni agricole distillate utilizzando legna anziché carbone importato). Vi fu addirittura un boicottaggio dei primi sull’aeronautica che dovette rassegnarsi a produzione nei propri impianti attraverso la barbabietola ma importando i macchinari dall’estero (!). Il monopolio boicottò queste importazioni tanto che i militari si trovarono con enormi quantità di barbabietole da non poter utilizzare e da dover alla fine svendere al monopolio medesimo (tanto per capire come funzionavano le cose nel nostro stupendo Paese).
Altra possibile fonte di carburanti nazionali sarebbero dovute essere le strapubblicizzate rocce asfaltiche e bituminose ma, a fronte di importanti investimenti dell’IRI per tecnologie che permettessero il loro sfruttamento, non si ottenne praticamente nulla.
Un prodotto da affiancare ai carburanti era il lubrificante ed il problema del suo approvvigionamento sembrava fosse risolto affidandosi all’olio di ricino prodotto in Val Padana. Era l’Aviazione che, anche qui, necessitava più lubrificanti e ne comprava quasi l’intera produzione nazionale. Solo che tale produzione era insufficiente ed il governo non aveva autorizzato l’estensione delle colture di ricino. Così che il prezzo del prodotto diventò sempre più elevato senza che i produttori sentissero la necessità di aumentare la produzione pur avendo promesso all’esercito una produzione tripla di quella effettiva. Alla fine delle sanzioni si scoprì che, anche qui, vi era stata una gigantesca truffa ai danni dell’erario e dell’esercito nelle sue esigenze di difesa nazionale se ben il 93% dell’olio di ricino occorrente era stato importato. Solo a questo punto si capì che conveniva ritornare ai lubrificanti minerali anche perché con l’olio di ricino si avevano frequenti congelamenti, odore nauseabondo, pistoni incollati ai cilindri, irrancidimento e quindi impossibilità d’uso dopo un dato tempo.
A partire dal 1936, il sistema sul quale si concentrò maggiormente l’attenzione tecnico scientifica fu però quello del gassogeno. Vi erano stati dei precedenti tentativi dal 1934 ma non avevano dato risultati promettenti e la cosa era stata abbandonata. Poi fu il governo che per decreto (R.D.L. 21 novembre 1935, n. 2234) stabilì che dal 1° gennaio 1938 tutti gli autobus fossero azionati in modo autarchico mediante carburanti nazionali, non meglio specificati, a parte, appunto, il gassogeno (e fu così che gassogeno divenne sinonimo di carburante nazionale anche se Mussolini non citò mai quel sistema nel suo discorso del 23 marzo). Ed a proposito del gassogeno scrive Maiocchi:
Fu soprattutto nel settore del trasporto pubblico cittadino che il gassogeno trovò applicazione pratica, dapprima a Milano, poi a Roma, e via via in altre città, con 1’adozione di modelli prodotti dall’ Alfa Romeo, che lavorava su licenza svizzera, e dalla FIAT, la quale costruiva il gassogeno “Nostrum”. La maggior parte delle aziende di trasporto preferì modificare i mezzi già in servizio anziché comprarne di nuovi, nonostante l’alto costo di trasformazione che raggiungeva le 20.000 lire. Il tutto avvenne però con molta lentezza e alla fine del 1936 risultavano in circolazione 240 autobus a gassogeno, di cui 56 nuovi e 184 trasformati, su un totale di circa 5.500. Dal punto di vista tecnico il gassogeno aveva raggiunto rendimenti abbastanza soddisfacenti e trovava largo impiego in vari Paesi, come Francia e Germania, ove si cercava di applicare questo propulsore non solo ad auto e autocarri, ma anche a motociclette, motrici ferroviarie, navi e persino aerei. Il Comitato tecnico corporativo dei combustibili liquidi attribuiva molta importanza a questa fonte di energia e alla fine del 1936 stimò che, senza tagliare un solo albero, utilizzando nei gassogeni solamente i rami caduti, materiale ricavabile dal dirado delle ceppaie e dalla potatura, si sarebbero potute ottenere annualmente 750.000 tonnellate equivalenti di benzina, molto più del consumo annuo italiano. Ma il vero ostacolo alla diffusione dell’ autotrazione a gassogeno era rappresentato proprio dalla difficoltà della raccolta del legname, dallo stoccaggio e dalla distribuzione del carbone di legna, molto più ingombrante e di più difficile trasporto della benzina o di altri combustibili liquidi. L’organizzazione di una efficace rete di “distributori di carbonella” si rivelò un ostacolo durissimo, sempre trascurato dagli entusiasti sostenitori del gassogeno.
Ma vediamo con qualche dettaglio cos’è il gassogeno e come fu applicato ai mezzi di trasporto.
9 – IL CASO DELLA TRAZIONE: GLI AUTOVEICOLI A CARBURANTI NAZIONALI
Le notizie e le figure di questo paragrafo provengono tutte da un libretto dell’Ing. Serafino de Capitani che riporto nelle parti di maggiore interesse.
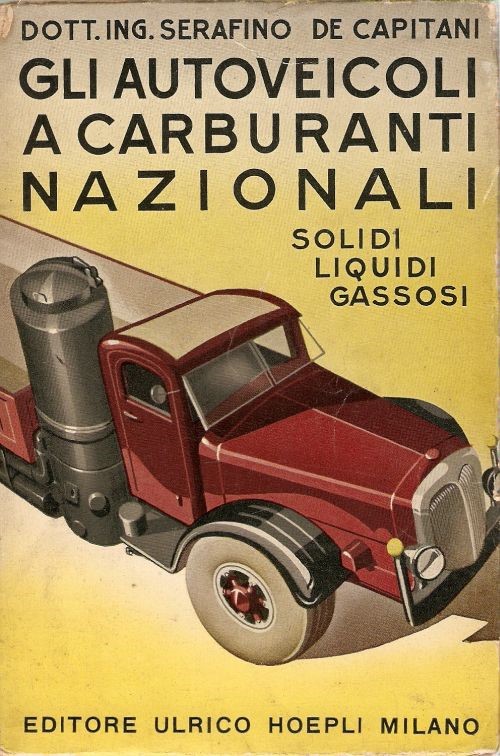
CAPITOLO SECONDO
I CARBURANTI SOLIDI ED I GASSOGENI
I CARBURANTI SOLIDI
I carburanti solidi sono quei combustibili che, previamente gassificati entro speciali apparecchi (gassogeni) applicati al telaio dell’autoveicolo, forniscono una miscela esplosiva capace di alimentare i comuni motori a scoppio oppure i motori Diesel, opportunamente trasformati.
Sono da citare in questa categoria : la legna, il carbone di legna, le torbe e le ligniti, i semi-cokes di lignite e gli agglomerati vari a base carboniosa. In alcuni gassogeni, nei quali mediante insufflazione d’aria nel focolaio vengono ottenute delle temperature di regime molto elevate, è anche possibile utilizzare come combustibile dei carboni fossili magri, cokes e semicokes di varia origine, ed agglomerati composti in prevalenza di carboni minerali.
I GASSOGENI
Generalità.
Si chiamano gassogeni quegli apparecchi che consentono di trasformare alcuni combustibili solidi in combustibili gassosi, per mezzo di una loro combustione imperfetta che dà luogo alla formazione di sostanze gassose pure combustibili, atte ad alimentare dei motori a gas o dei motori a combustione interna.
In generale in un gassogeno si distinguono le seguenti parti principali:
1°) Il generatore propriamente detto, che consiste in una specie di stufa entro la quale avviene la combustione parziale (distillazione) di un combustibile solido e la sua trasformazione in sostanze gassose.
2°) Il serbatoio, che contiene il combustibile destinato ad assicurare una certa durata di funzionamento senza bisogno di ricarica.
3°) Gli apparecchi di raffreddamento del gas; i quali hanno. lo scopo di abbassare la temperatura di quest’ultimo (che all’uscita dal gassogeno supera i 500°) in modo da ridurla a valori compatibili col buon rendimento del motore. È noto infatti che quanto minore è la temperatura del gas, tanto maggiore risulta la densità di quest’ultimo e quindi la quantità di esso che viene aspirata nell’unità di tempo dal motore.
4°) Gli apparecchi di depurazione o depuratori, i quali hanno lo scopo di togliere dal gas tutte le impurità solide o liquide che esso ancora contiene all’uscita del gassogeno e far sì che al motore arrivi un gas privo di ogni sostanza nociva, che potrebbe provocare corrosioni, incrostazioni od altri deterioramenti del motore stesso.
5°) Dispositivi (normalmente detti «miscelatori»), che sostituiscono i comuni carburatori dei motori a scoppio ed hanno lo scopo di provocare la formazione di una miscela esplosiva (composta dal gas e da aria in proporzioni opportune) atta ad accendersi sotto l’azione della scintilla ed a mettere quindi in movimento il motore.
Come funziona il gassogeno.
Le reazioni che avvengono nel gassogeno sono piuttosto complesse, ma si possono, per semplicità, schematizzare così:
L’aria atmosferica, richiamata dalla aspirazione del motore oppure inviata da un apparecchio soffiante, penetra nel generatore dove, al contatto delle sostanze carboniose incandescenti, dà luogo alla combinazione del suo ossigeno col carbonio di queste ultime. Fra il carbone e l’aria di alimentazione del focolare ha luogo dapprima la reazione seguente: C + O2 = CO2 + 97 calorie.
Si forma cioè anidride carbonica, con sviluppo di calore, il quale aumenta la temperatura dell’aria di alimentazione e quella del focolare e rende così possibile la seconda reazione, destinata a trasformare l’anidride carbonica prodotta in un primo tempo (e che è un gas inerte e perciò inutilizzabile) in ossido di carbonio (gas combustibile). All’alta temperatura ottenuta nella prima reazione ed in presenza di un eccesso di carbonio, l’anidride carbonica si trasforma dunque secondo la reazione: CO2 + C = 2 CO – 39 calorie.
Questa seconda reazione avviene con assorbimento di calore e perciò la temperatura del focolare e quella del gas prodotto si abbassano. Delle 97 calorie sviluppatesi durante la prima. reazione ne restano infatti disponibili ora soltanto 58, ossia 29 per ciascuna delle due molecole di ossido di carbonio che si sono venute a formare. La reazione complessiva che avviene nel gassogeno si può quindi rappresentare così: C + O = CO + 29 calorie.
Il gas così ottenuto («gas d’aria») esce dal gassogeno alla temperatura di circa 600° mentre per ottenere un buon rendimento del motore è invece necessario, per il motivo già accennato, che esso sia il più freddo possibile.
Ad abbassare la temperatura del gas prodotto può anzitutto servire la cosiddetta iniezione d’acqua. Nella sua realizzazione più semplice la si può ottenere munendo il gassogeno di un piccolo serbatoio d’acqua e facendo ad es. in modo che il gas prodotto, uscendo dal focolare, venga a lambire la massa di acqua contenuta nel serbatoio e ad arricchirsi così di vapor acqueo ed a raffreddarsi alquanto.
Inoltre quest’ultimo, scindendosi nei suoi due componenti (ossigeno ed idrogeno) per effetto dell’alta temperatura, arricchisce di idrogeno il gas, col vantaggio di aumentarne il potere calorifico e quindi la forza esplosiva. Il raffreddamento così ottenuto non è tuttavia sufficiente e bisogna ricorrere, come si vedrà, ad altri sistemi.
Nei gassogeni provvisti di dispositivi per la iniezione d’acqua, il gas prodotto è un gas misto (ossia una miscela di gas d’aria e di gas d’acqua); esso risulta essenzialmente composto da ossido di carbonio, azoto ed idrogeno, ed ha un potere calorifico variabile dalle 1200 alle 1400 calorie per mc. La reazione prodotta dall’iniezione d’acqua è la seguente: C + H20 = CO + H2 – 28 calorie. Molto importante è la regolazione della iniezione d’acqua, regolazione che in alcuni gassogeni è automatica. Se l’acqua aggiunta fosse in quantità troppo grande, essa eserciterebbe un’azione dannosa perchè abbassando di troppo la temperatura del focolare, renderebbe incompleta la seconda delle reazioni viste sopra, dando così luogo ad una eccessiva formazione di anidride carbonica (gas inerte); inoltre una eccessiva proporzione d’idrogeno nel gas potrebbe dar luogo a fenomeni di detonazione nel motore. In alcuni gassogeni per autoveicoli si preferisce pertanto rinunciare, per semplicità di costruzione e di impiego, all’aumento di potere calorifico prodotto dalla iniezione d’acqua: ciò avviene specialmente per quelli destinati ad applicazioni coloniali. Il gas prodotto ha in tal caso un potere calorifico variabile fra le 850 e le 1100 calorie per mc e contiene dal 20 al 30 % di ossido di carbonio, dal 3 al 6 % di anidride carbonica, dal 60 al 65 % di azoto e dal 2 all’11 % di idrogeno. Nei gassogeni a legna non è necessaria la iniezione d’acqua per il fatto che il combustibile impiegato, anche se a secchezza mercantile, contiene sempre una percentuale d’acqua sufficiente per produrre una quantità di vapor d’acqua tale da assicurare un efficace arricchimento del gas prodotto.
Nei gassogeni ad alta temperatura di regime si giunge direttamente alla formazione dell’ossido di carbonio senza passare per la fase intermedia di anidride carbonica.
Il gas prodotto nel gassogeno, mescolato ad una opportuna quantità di aria in un apposito «miscelatore» (che fa qui le veci del carburatore) forma con essa una miscela esplosiva analoga a quella fornita dall’aria e dai vapori di benzina, oppure dall’aria e dai vapori di nafta, e quindi capace di azionare il motore, se immessa nei cilindri.
I gassogeni possono essere divisi in due tipi principali: quelli a tiraggio diretto e quelli a tiraggio rovesciato. Nei primi l’entrata dell’aria e quindi la combustione si effettuano dal basso in alto come nelle stufe comuni. Nei gassogeni a tiraggio rovesciato l’aria è fatta invece entrare dall’alto e la combustione procede dall’alto verso il basso: in tal modo i prodotti acidi o catramosi vengono ad essere attratti e bruciati nella zona centrale di combustione. Una soluzione intermedia è quella del così detto «tiraggio inclinato» pure adottato in alcuni tipi di gassogeno.
Ognuno di questi tipi presenta vantaggi e svantaggi nei rapporti degli altri. In tesi generale si può tuttavia ritenere che i gassogeni a tiraggio diretto danno luogo a minori perdite di carico nel gas prodotto ma esigono una successiva maggior depurazione di quest’ultimo, mentre quelli a tiraggio rovesciato forniscono un gas più puro ma danno luogo a maggiori perdite di carico nel medesimo. I primi si prestano in modo particolare per l’impiego di carbone di legna, di agglomerati ed in genere di combustibili che forniscono bruciando scarse quantità di prodotti acidi o catramosi, mentre i secondi sono particolarmente indicati per la utilizzazione della legna, la quale svolge bruciando notevoli quantità dei prodotti suddetti, che devono venir decomposti nell’interno del gassogeno, altrimenti danneggerebbero i cilindri del motore. Anche per l’impiego dei combustibili fossili ed in particolare dei carboni minerali grassi è da consigliarsi la adozione di gassogeni a tiraggio rovesciato.
Qualunque sia il tipo di gassogeno adottato è ad ogni modo necessario procedere, come si disse, al raffreddamento, ed inoltre alla depurazione del gas prima di immetterlo nei cilindri del motore.
È infatti indispensabile depurare il gas dalle molte sostanze solide che porta in sospensione (polvere di carbone, particelle catramose, ecc.) per impedire che queste, giungendo nel motore, possano danneggiarlo, rigando i cilindri o sporcando la testa, le pareti, le sedi delle valvole e le altre parti del motore.
Ad ogni gassogeno sono quindi annessi dei dispositivi, detti depuratori-raffreddatori, nei quali si fa circolare il gas attraverso ad una serie di resistenze di vario tipo (molle metalliche, acqua, pezzetti di coke, ecc.), ottenendo contemporaneamente il risultato di depurare il gas e di raffreddarlo.
Un filtro di sicurezza, collocato poco prima del tubo di ammissione del gas al motore e formato generalmente da un complesso di sottili reti metalliche, ha lo scopo di trattenere le eventuali impurità residue del gas.
La perfezione raggiunta dagli odierni sistemi di raffreddamento e di depurazione del gas è documentata dal fatto che oggi è possibile percorrere parecchie centinaia di chilometri senza dovere ricorrere alla pulizia del depuratore e del filtro, e che i motori degli autoveicoli alimentati a gassogeno non presentano né incrostazioni né deterioramenti anche dopo aver funzionato per migliaia di chilometri.
E’ d’interesse passare a vedere alcune foto di mezzi alimentati a gassogeno ed alcuni schemi di funzionamento.


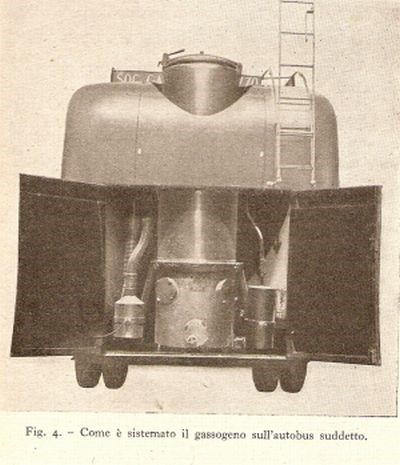

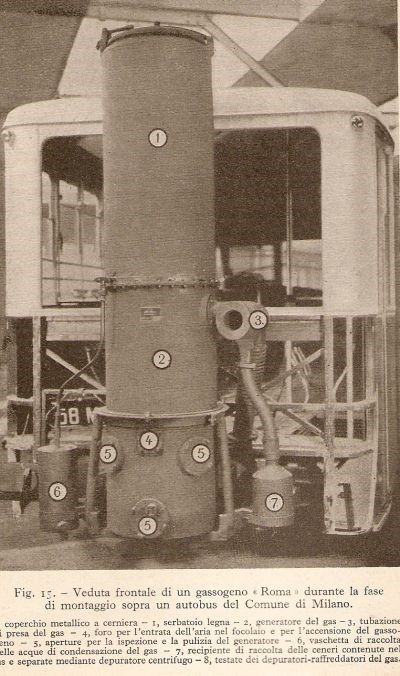
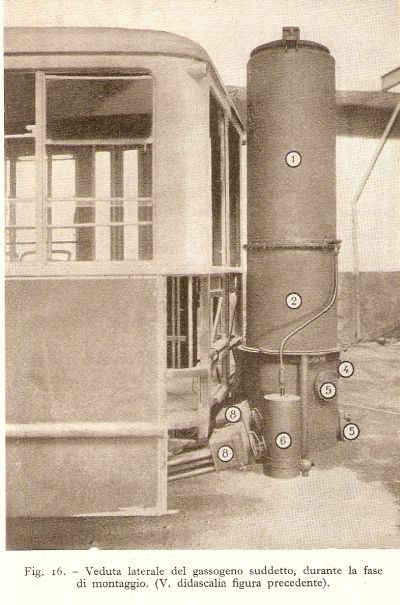
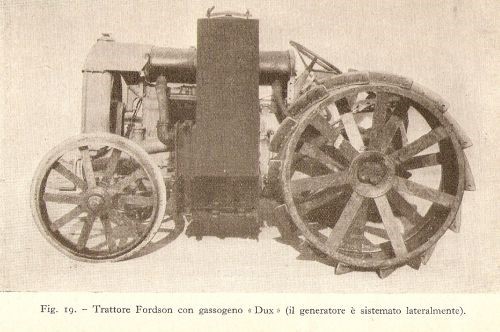
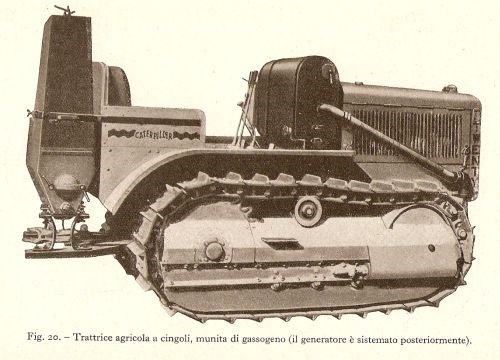
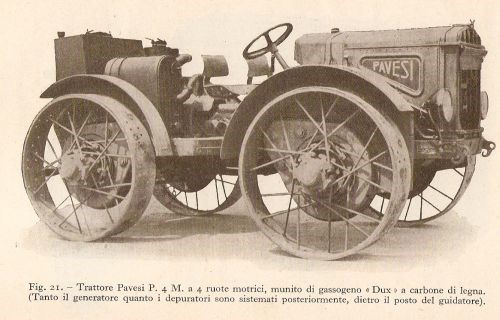



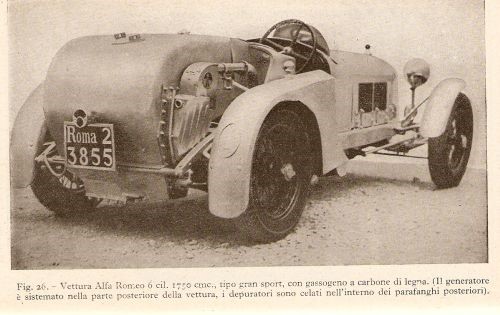


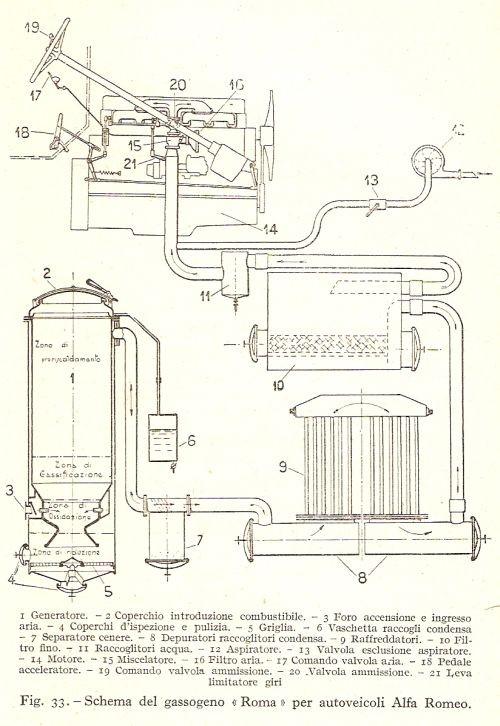
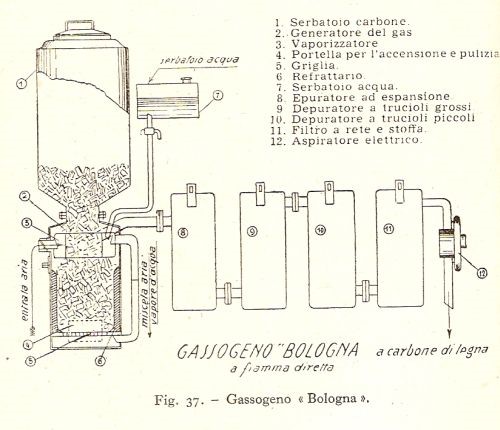
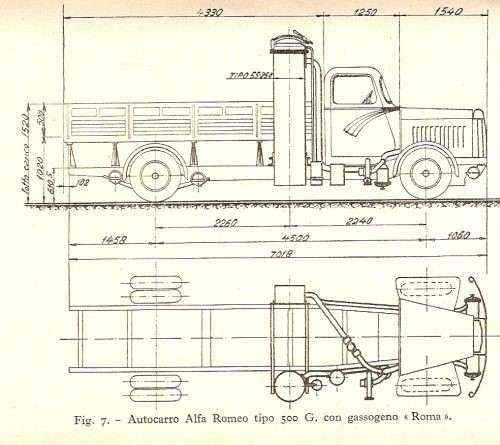
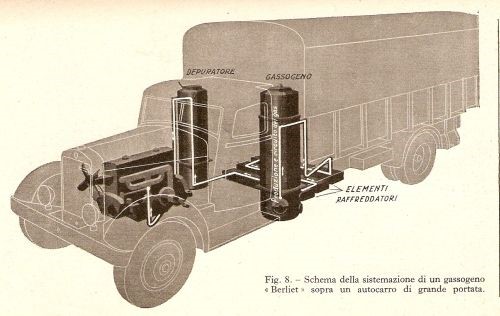
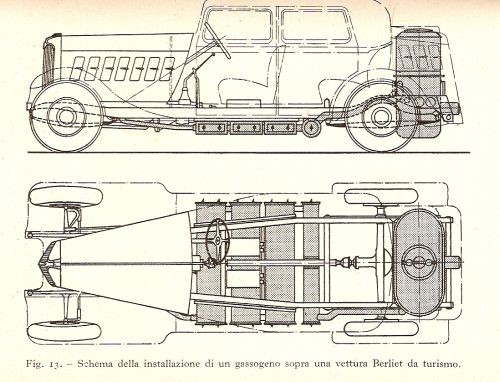
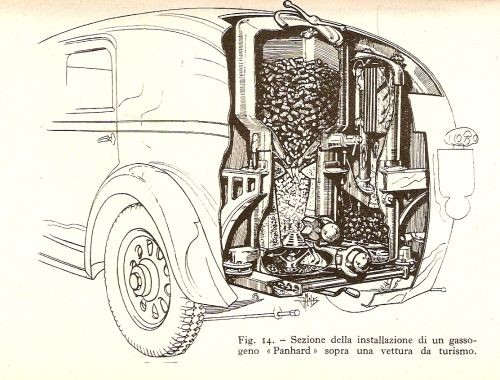
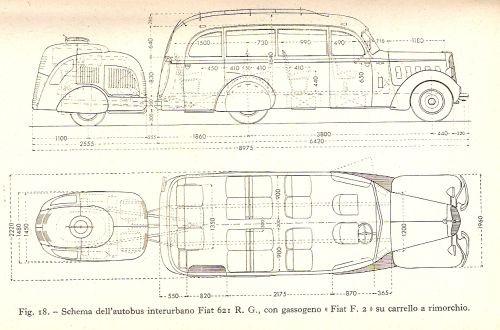
Di progetti di gassogeni se ne fecero in grande quantità e ad essi furono interessate oltre alle grande fabbriche di automobili, anche piccole aziende localizzate un poco per tutta l’Italia centro settentrionale. Oltre a quelle viste vi furono applicazioni militari (molto limitate in carri armati), su moto e su barche.
Anche se promettente, almeno per un uso di trazione per autobus, autocarri ed automobili, gli obiettivi del decreto legge sembravano irreapizzabili. E lo furono anche se vi fu una proroga di 6 mesi. Alla fine del 1937 gli autobus a gassogeno erano 303, con un aumento di 63 unità in un anno. Altri 300 erano in lavorazione mentre per 604 vi erano dei progetti di trasformazione. Analoga sorte ebbero i progetti di alimentazione con gas naturale (il metano scoperto mentre si ricercava petrolio), con alcool metilico. Peggio andò con l’alcool etilico: il progetto era di fa r muovere 3354 autobus con questo carburante (mescolato con benzina). Alla cadenza del progetto un solo mezzo era mosso con tale carburante.
E’ inutile insistere. Sembra chiaro che la situazione era completamente scoordinata tra ogni settore politico, decisionale, tecnico e produttivo. Si cercavano sempre grandi guadagni con faraonici progetti che, a fronte di ingentisime spese ed arricchimenti andavano a finire nel nulla, quando non nel ridicolo. Credo si possa dire che, guardandoci seriamente intorno, nulla sia cambiato.
10 – LE DISPONIBILITA’ ENERGETICHE ITALIANE: L’IDROELETTRICITA’
L’Italia non ha mai avuto disponibilità energetiche da combustibili fossili. Poco si poteva ottenere da lavorazioni chimiche di prodotti agricoli. Una sua vera ed enorme ricchezza era l’idroelettricità (tanto è vero che le circolari del regime, prima di spingere su qualunque succedaneo, chiedevano sempre che si dovesse utilizzare, per qualunque funzione, innanzitutto energia elettrica).
La struttura orografica ed idrografica del Paese aveva permesso, agli albori dell’elettricità, di imbrigliare molta acqua sia in quota che in collina. Si deve poi notare che proprio tale sviluppo della fonte aiutò la realizzazione di apparati tecnici estremamente competitivi a livello europeo. Ho parlato altrove dei nostri eccellenti Pacinotti e Galileo Ferraris è ora il momento di ricordare la metadinamo (una macchina elettrica a corrente continua che può servire come trasformatore, come generatore o come motore, in grado comunque di ridurre del 20% i consumi dell’autotrazione)(7) dell’ingegnere italo graco Massimo Giuseppe Pestarini, macchina dalle grandi prestazioni entrata in produzione presso la San Giorgio anche se per breve tempo. Altro problema tecnico che venne affrontato fu quello dello sviluppo delle batterie, di grande interesse per l’esercito. Anche qui mancava la materia prima, il biossido di manganese, che dovevamo importare e ciò rendeva il problema di difficile soluzione. Ma la lungimiranza del nostro governo voleva imporre addirittura la trazione a batteria, con qualche tecnico servile che annuiva, estendendola fino ai carri funebri (per non dire di chi voleva passare all’aratura elettrica).
Sullo sviluppo dell’industria elettrica negli anni che discuto, dice Bruno Caizzi:
Né incertezze postbelliche (Prima Guerra Mondiale), né deflazione, né crisi valsero veramente ad arrestare per lungo tempo il cammino dell’industria elettrica, le cui ambizioni assecondavano, da una posizione privilegiata di potere economico, uno dei maggiori bisogni del paese.
L’industria elettrica aveva spiccato un primo balzo importante nel secondo decennio del secolo, ma moltissimo le restava da fare per sfruttare le risorse naturali della penisola e dare all’Italia un apporto energetico adeguato alle esigenze della sua vita industriale e civile.
La ricerca di bacini montani da imbrigliare, la costruzione di nuovi impianti, la trasformazione di quelli esistenti, era proseguita alacremente dopo il 1922, senza che ombra di crisi scendesse mai sull’industria, quasi ch’essa fosse staccata dalla congiuntura, poiché restava da riempire un grosso vuoto di produzione. Nel 1923 una delle maggiori società elettriche, la Conti, che tre anni dopo sarebbe confluita nel complesso Edison, distribuiva un dividendo del 10 % e il suo promotore annotava nel proprio taccuino che per le imprese del ramo il solo vero problema consisteva nel cercare di far fronte alla richiesta crescente del mercato.
Fra il 1918 e il 1925 il gruppo elettrico conquistava il primo posto, quanto a valore di investimenti, fra i gruppi economici operanti in Italia, e negli anni successivi rafforzava questo suo primato. Mentre nel 1918 le società esercenti trasporti avevano ancora il capitale più elevato (1.868 milioni di lire), seguite dalle banche, e le imprese elettriche venivano quarte (1.069 milioni), superate anche dalle industrie meccaniche, nel 1928 la graduatoria era sconvolta a vantaggio delle 496 società elettriche il cui capitale complessivo rappresentava ormai oltre la sesta parte di quello investito nelle società d’ogni genere. La Edison, che fra il 1922 e il 1933 decuplica quasi il proprio capitale, portandolo da 165,6 a 1.485 milioni, e che opera anche con ingenti mezzi finanziari attinti al mercato del credito obbligazionario e bancario, rappresenta in pari tempo il maggior gruppo elettrico della penisola e la maggiore società industriale e finanziaria italiana. Numerose imprese associate fanno capo alla Edison: di produzione e distribuzione dell’energia le più, ma pure d’altri settori, variamente interessati al consumo di energia: ferrovie, tramvie, funicolari, industrie meccaniche, imprese di fornitura del gas, ecc. Nel 1933 il gruppo Edison da solo fornisce al mercato energia per 2.514 milioni di kwh, destinati in parte a usi civili, ma in misura assai maggiore alle industrie dislocate nelle province di massimo sviluppo economico, nelle quali la Edison e le sue consociate avevano esteso la rete dei propri servizi [è utile qui inserire un dato fornito da Eugenio Scalfari in Storia segreta dell’industria elettrica (Laterza 1963): “E’ opportuno dare qui un ragguaglio analitico di che cosa fosse diventato il gruppo Edison nel 1934; è questo il modo migliore per dare un’idea della potenza raggiunta dalla maggiore impresa elettrica italiana. I capitali investiti nelle società elettriche controllate dalla Edison ammontavano a 5.414 milioni; quelli investiti in società non elettriche a 752 milioni; gli utili distribuiti in
quell’anno furono di 211 milioni.”]
Il progresso finanziario dell’industria elettrica era largamente giustificato dalla sua intraprendenza tecnica ed economica, e dall’incremento della forza prodotta, che raggiunge indici non toccati in altri settori. Fra il 1918 e la fine del 1932 la potenza installata negli impianti elettrici passa da 1,28 milioni di kw a 5,15 milioni, con un parallelo cospicuo incremento dell’energia immessa nella rete di distribuzione. […]
È dunque nel settore elettrico che fra le due guerre s’è formato il più grosso nucleo di industria capitalistica: tale, non solo o non tanto per l’entità dei capitali investiti, ma anche e soprattutto per la preponderanza e l’alta qualificazione degli impianti, e il carattere spersonalizzato dell’impresa che attinge i propri mezzi attraverso una vasta diffusione di azioni e la contrazione di grossi prestiti. L’industria elettrica, e in questo occorre coglierne un’altra caratteristica, è strumentale, nel senso che il bene da essa prodotto è in parte destinato a consumo diretto e improduttivo ma in parte maggiore interviene come materia prima di altri cicli lavorativi. Dalla disponibilità di forza è dipeso il progresso della trazione ferroviaria e tramviaria, la meccanizzazione di numerose industrie, l’esistenza stessa di certe lavorazioni chimiche o alimentari. Per questo lo sviluppo dell’industria elettrica riflette nei suoi vari gradi e momenti lo sviluppo stesso dell’apparato produttivo nazionale. Nel 1932 gli 8.682 milioni di kwh consumati si distribuivano a questo modo fra i diversi gruppi di utenti:
1.070,4 per illuminazione e riscaldamento;
4.160,4 per forza motrice di stabilimenti industriali;
762,5 per forza di trasporto;
2.688,7 per i bisogni delle industrie chimiche e metallurgiche.
Quell’anno, in particolare, le industrie tessili consumarono 890 milioni di kwh; le alimentari 551 milioni; le meccaniche e affini 444 milioni; le metallurgiche 426 milioni; le cartarie 323 milioni; le chimiche 318 milioni; le edilizie, infine, 246 milioni.
Le imprese elettriche agivano in condizioni assai favorevoli per ridurre al minimo le conseguenze negative anche della grande crisi. Il gioco di mercato, che tanto deprimeva altri settori, le sfiorava appena. Esse non avevano da temere né la concorrenza estera, materialmente impossibile, né quella interna, evitata da un’attenta distribuzione delle rispettive zone d’influenza e da tutta una serie di intese e coordinamenti aziendali. Il rinvio a tempi migliori di alcune progettazioni e un certo ripiegamento nelle vendite, che avrebbe forse potuto venire evitato attraverso minore rigidezza dei prezzi, furono il non cospicuo tributo pagato dall’industria elettrica alla crisi che aveva travolto tanti altri settori.
Qualche polemica sul carattere monopolistico dell’industria non trovava lunga eco; qualche discussione sui prezzi ai quali l’energia veniva venduta si smorzava nella complessità dei controlli, nelle difficoltà di districare la matassa arruffata di impianti nuovi e impianti vecchi, costi fissi e costi variabili, energia normale ed energia di supero, obsolescenza delle condotte, tassi di ammortamento e via di seguito. Molte industrie di trasformazione lamentavano, probabilmente non a torto, che l’energia costava troppo, e guardavano con sospetto a quel gruppo di imprese fornitrici i cui affari prosperavano malgrado i tempi, e che distribuivano ottimi dividendi e accumulavano cospicue riserve. Le grandi imprese industriali avevano cercato da un pezzo di svincolarsi da quella sudditanza difficile, costruendosi per proprio conto gli impianti che le rifornissero di energia di cui avevano bisogno; ma in balìa delle tariffe elettriche imposte restavano la media, la piccola industria e l’artigianato. In questo senso la politica delle industrie elettriche, assai scarsamente vigilata e corretta dal governo, e da questo anzi favorita e benevolmente assecondata, poté agire come freno alla ripresa economica dal basso allorché la crisi accennò a esaurirsi.
I gruppi finanziari e industriali italiani si erano fortemente combattuti per assicurarsi il controllo dell’energia elettrica; ma la loro lotta poteva dirsi conclusa nel 1933, quando le rispettive posizioni s’erano consolidate, e le grandi società concessionarie, mentre si sentivano sodali di fronte al potere pubblico che poteva frenarne l’azione, badavano ormai soprattutto a rafforzare la rete delle proprie interessenze.
Con la fondazione dell’IRI, l’ente statale che aveva raccolto una grossa eredità del portafoglio azionario italiano, quei vincoli fra l’industria elettrica e le banche, ch’erano strettissimi sin dai tempi della Edison, si spezzano. Dagli istituti che avevano richiesto il suo intervento, l’IRI ereditava un nutrito pacco di interessenze elettriche, fra cui quella della SIP [Società Idroelettrica Piemontese] e della UNES [Unione Esercizi Elettrici]; era inoltre caduta nelle braccia dell’IRI la Bastogi, attraverso la quale veniva assicurato il controllo sulla Meridionale di elettricità, della quale del resto un’altra quota di capitale era già finita all’IRI per altre vie. Per quanto restassero fuori dell’influenza del nuovo istituto imprese importantissime, come Edison e SADE [Società Adriatica di Elettricità], ve n’era abbastanza per poter imprimere al settore elettrico un preciso indirizzo ispirato a finalità generali di sviluppo, indirizzo che avrebbe avuto decisivi riflessi anche nel comportamento delle altre imprese elettriche sottratte a diretto controllo statale. Avvenne invece che proprio in questo campo la condotta dell’IRI rimase passiva e ancorata a concezioni privatistiche, come se l’Istituto avesse esaurito i suoi specifici compiti dopo aver messo al sicuro quel gruppo di titoli. L’IRI non parve infatti attribuire particolare valore alle leve di intervento di cui disponeva e anzi, appena gli fu possibile s’affrettò ad alleggerire le sue responsabilità trasferendo a privati il pacco Bastogi, il cui controllo venne assunto da un consorzio di potenti gruppi economici formato da Pirelli, Fiat, Centrale, Montecatini, Edison, SADE, Generali di Venezia. In quanto a ciò che restava di portafoglio elettrico, si dovette attendere fino al 1952 per vederlo raggruppato organicamente nella Finelettrica, holding che nacque con inspiegabile ritardo rispetto agli altri capigruppo dello stesso genere.
Il fascismo, che non intendeva minimamente creare un antagonismo competitivo fra il settore elettrico privato e quello pubblico, continuava a considerare con molta indulgenza le richieste delle grandi industrie non solo in materia di tariffe, ma pure di concessioni e di sovvenzioni per impianti. Appunto nel ’33 vennero emanate due disposizioni molto significative; l’una che prorogava gratuitamente fino al 1977 tutte le derivazioni d’acqua ad uso di forza motrice accordate in base alla legislazione precedente (molte delle quali
stavano per giungere in scadenza), l’altra che decretava una serie di contributi elargiti dallo Stato a fondo perduto: alla costruzione di linee da approntare entro il 1940, agli impianti costruiti tra il 1925 e il 1940, alle costruzioni di nuovi serbatoi per l’invaso delle acque.
Questa politica di condiscendenza, che pesava abbastanza duramente sui consumatori di energia e sull’erario, ebbe almeno il merito di non rallentare di molto il ritmo di sviluppo degli impianti, accrescendone il potenziale di sfruttamento anche negli anni più difficili del primo dopoguerra. La costruzione di grandi elettrodotti, destinati a consentire il trasporto a distanza dell’energia, dette l’avvio a quell’unificazione del mercato elettrico che sarebbe stata portata a compimento nel secondo dopoguerra, consentendo intanto utili scambi di energia fra le diverse regioni che la producevano in regimi climatici molto diversi, per cui l’eccesso di corrente di un gruppo di centrali alpine faceva riscontro spesso a una temporanea deficienza delle centrali appenniniche, o viceversa. Inoltre fra il 1933 ed il 1939 la produzione di energia passò da 11,6 a 18,4 miliardi di kwh, con fortissima preponderanza dell’energia idroelettrica, mentre restavano entro termini assai ridotti i contributi di quella termica o geotermica.
I dati sulla produzione elettrica italiana nel periodo precedente la Seconda Guerra Mondiale sono riportati di seguito.
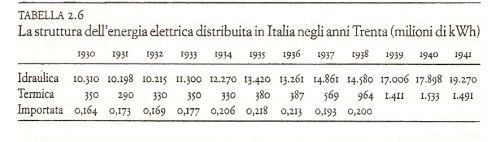
La politica dell’Industria elettrica e particolarmente della Edison, come visto, era stata fondamentalmente tesa al massimo profitto con totale disinteresse degli usi elettrici più utili alla popolazione. Si erano privilegiati grandi consumatori che garantivano una costanza di richiesta elettrica e risultavano concentrati in zone ristrette. In tal senso le industrie elettrochimiche ed elettrometallurgiche erano favorite, anche nelle tariffe, rispetto agli usi domestici (particolarmente quelli in paesini distanti dalle centrali di produzione), a quelli agricoli (per definizione dispersi nel territorio) e a quelli della trazione (tram e filobus perché ancora non si disponeva di una diffusa elettrificazione delle ferrovie). La Edison riusciva addirittura a giustificare la sua politica rispetto agli usi domestici dell’elettricità con argomenti ancora oggi molto seri ma dietro i quali si nascondeva solo il profitto: non è energeticamente efficiente riscaldare le case case e cucinare con energia elettrica (sarebbe d’interesse che i produttori di energia elettrica lo ricordassero invece di spingere verso lo stupido nucleare). E l’interesse degli industriali era corporativamente suddiviso in zone d’influenza di modo che gli industriali del gas sostenevano la politica degli elettrici.
Ma vi era un problema di fondo che riguardava la produzione e l’uso elettrico in Italia. La suddivisione del territorio in differenti aziende elettriche era anche suddivisione in zone di mercato in cui non era prevista concorrenza. E questa struttura non disponeva di significative connessioni tra la rete di una azienda con quella di un’altra. Mancava cioè l’interconnessione elettrica, una qualche linea ad alta tensione che collegasse tra loro l’intero sistema (per fare l’interconnessione sarebbe stato prima indispensabile unificare le frequenze di funzionamento della corrente alternata). Ciò era costoso e figurarsi se l’azienda elettrica privata si sarebbe accollata una spesa come questa comunque di enorme utilità (quando una centrale va fuori servizio viene sostituita da un’altra e si garantisce sempre il servizio (non era quella ancora l’epoca della previsione della riserva elettrica). Inoltre l’interconnessione era ambita dai militari perché, in caso di eventuale conflitto, sarebbe stato strategico spostare energia da un luogo ad un altro del Paese. L’autarchia aiutò sulla strada dell’interconnessione poiché venne argomentato che se non si poteva spostare energia da una parte all’altra del Paese sarebbe stato necessario servirsi di centrali termoelettriche con conseguente aumento d’importazione di combustibili fossili. E l’autarchia pose al centro delle problematiche anche la sostituzione del rame con l’alluminio.
Ancora nel 1936, comunque, l’industria elettrica con la Edison alla testa tentava di bloccare in ogni modo l’autoproduzione elettrica da parte delle grosse industrie sia chimiche che metallurgiche. Anche nuove centrali non erano in programma perché si sosteneva che l’energia elettrica prodotta era sovrabbondante rispetto alla richiesta. Bastò però l’inverno del 1936-37 per mostrare che quanto sosteneva la Edison era falso e serviva solo per mantenere la produzione al limite risparmiando sulla costruzione di nuove centrali e per tenere i prezzi del kwh alti. Questa eventualità, unita alla spinta autarchica che voleva spostare molti usi verso l’elettrico (ad esempio la trazione urbana ebbe un forte impulso verso l’elettricità attraverso tram e filobus), costrinse alla costruzione di nuove centrali ma in condizioni sfavorevoli rispetto a quanto si sarebbe ottenuto con una gradualità nel tempo. Erano infatti saliti di molto i costi delle materie prime.
11 – IL CNR DI FRONTE ALL’AUTARCHIA
Le sanzioni verso l’Italia sembrarono muovere il governo verso una effettiva utilizzazione della scienza e della tecnica attraverso il CNR. Si rispolverarono vecchie relazioni per tentare di capire davvero cosa si volesse e come sarebbe stato finanziato. Intanto si organizzavano spedizioni in Etiopia per vedere quali ricchezze (materie prime) quel territorio poteva fornire all’Italia.
La svolta, come era costume, la doveva dare Mussolini con un suo discorso del 23 marzo 1936 all’Assemblea Nazionale delle Corporazioni. Tra l’altro egli disse:
Per vedere se e in quali limiti l’Italia può realizzare la sua autonomia economica nel settore della difesa nazionale, bisogna procedere all’inventario delle nostre risorse e stabilire inoltre quel che ci può dare la tecnica e la scienza. Per questo abbiamo creato e date le agevolazioni necessarie, al Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Al CNR ci credettero con emozione e si dettero subito da fare per essere pronti alle richieste attese, considerato che si aspettavano i desiderati finanziamenti. Ma non accadde nulla. Perché vi fosse uno spostamento significativo di denaro occorse attendere la Proclamazione dell’Impero che creò una grande euforia tra gli industriali, euforia che sfociò in donazioni che portarono il bilancio del CNR per il 1936-37 a circa 11 milioni e mezzo (10 volte più di quanto si aveva a disposizione nel 1934). Ma il direttorio del CNR era costituito da industriali e politici, con Giannini a guardia del fascismo, con solo due scienziati. Fu Blanc che sollevò il problema di sapere se la politica scientifico tecnica dovesse essere decisa da non scienziati e fu Giannini a riportare il discorso su il Duce ha sempre ragione !.
Si iniziò con il progettare i laboratori ambiti fin dalla fondazione del CNR ma si restava nella italica ambiguità giuridica: poteva il CNR fondare istituti autonomi rispetto a quelli universitari (dipendenti dal Ministero dell’Educazione) ? E qui iniziò uno scontro tra CNR e Ministero. All’inizio sembrò che il CNR dovesse dipendere dall’Università (tesi sostenuta dal Ministro dell’Educazione, Bottai) ma dopo una lettera di Marconi a Mussolini, si conquistò l’autonomia del CNR a partire da un decreto del luglio 1937. Tutto ciò fu pagato con circa un anno di paralisi del CNR. E pensare che gli scienziati erano diventati nazionalisti a partire dalle sanzioni e si sbracciavano come potevano per sostenere il governo(8).
Il problema principale restava comunque quello dei combustibili fossili ed una delle figure italiane che più si dedicò al problema e che aveva il maggior prestigio fu Mario Giacomo Levi., grande fascista e fervente sostenitore della politica autarchica. Il nostro scienziato, mentre nel Congresso della SIPS del 1937 sosteneva:
Nel 1931 nella XX riunione della nostra Società a Milano ebbi a trattare di una sola parte del problema considerando gli aspetti tecnici ed economici del problema dei carburanti. La mia fede, il mio entusiasmo ed il nostro lavoro non si erano allentati […] ma l’atmosfera italiana era scettica e pavida: prevalevano le considerazioni strettamente economiche […], Confesso che a quel Congresso io ho sofferto: da quelle riunioni io sono uscito disanimato e tormentato dal dubbio se veramente io non fossi un fissato ed un esaltato a voler ostinarmi nello studio di problemi che non presentavano per il nostro Paese né possibilità, né utilità […], E come oggi l’atmosfera è mutata! […]. Il terreno coltivato con coscienziosa fede, germoglia vigorosamente, gli indifferenti sono divenuti entusiasti, gli incompetenti si sono affrettati a studiare e sono divenuti sapienti, gli industriali, i tecnici, i capitali sono in piena mobilitazione, le nostre 130 pubblicazioni da ogni parte cercate, lette, esaurite. Le ragioni di tale mutamento sono note a tutti: per la terza volta in vent’anni il problema dei combustibili si è recentemente riaffacciato in Italia in tutta la sua violenta gravità, forse violenta come non mai, perché contro di noi fu coalizzato o si cercò di coalizzare tutto il mondo quando 50.000 italiani erano impegnati fuori della Patria in un altro continente a conquistare l’Impero: dalla rapidità, dai trasporti, dalla produzione, dalle armi dipendevano o la sfolgorante vittoria o il soffocamento e l’umiliazione; uniche materie prime sicuramente nazionali e sicuramente disponibili l’eroismo del nostro esercito di tutte le armi e di tutti i ranghi, la profetica veggenza e il superumano coraggio del Capo.
Quello stesso Capo, il Duce, che l’anno seguente, con le vergognose leggi razziali, lo cacciò da ogni incarico nonostante i suoi meriti scientifici e nei riguardi del fascismo.
Il problema dei combustibili veniva sempre più dibattuto ma non si usciva da quanto già detto: non si riusciva a risolvere il problema con l’aggravante gigantesca che l’Italia si preparava alla guerra in una situazione disastrosa di uno degli elementi fondamentali per sostenere un conflitto: i carburanti. Il governo emanò direttive per utilizzare combustibili nazionali specificando zona per zona quale fosse il combustibile più adeguato. Lo stesso Mussolini spinse per l’alcool da barbabietole e se Mussolini diceva qualcosa si muoveva anche se il problema restava: la produzione italiana di barbabietole non era sufficiente (si pensò allora ad altro, al sorgo e alla fermentazione del legno, ma con scarso successo; si lavorò anche sulle ligniti e sulle rocce asfaltiche ma con risultati vicini allo zero). Lo stesso gassogeno a carbone di legna che nelle previsioni avrebbe dovuto contribuire per il 4,2%, si mantenne molto al di sotto di tale previsione (mediamente un poco più di 2000 tonnellate di benzina equivalente l’anno in confronto alle 30000 preventivate). Questa situazione è così commentata da Maiocchi (2003):
All’inizio del 1940, dunque, la preparazione del cimento bellico basata sull’autarchia aveva determinato una situazione che non lasciava spazio ad alcun ottimismo: in caso di guerra ci occorrevano, per il primo anno, circa 8 milioni e mezzo di tonnellate di carburanti, se fossimo riusciti a importare senza ostacoli i rifornimenti per le nostre raffinerie, saremmo stati in grado di produrne meno di 2 milioni e mezzo, se invece fossimo stati costretti alle risorse nazionali avremmo potuto sfiorare le 150.000; si prospettava perciò un deficit di carburante che, nel caso peggiore sarebbe stato di poco meno di 8.500.000 di tonnellate e in quello migliore si sarebbe attestato attorno ai 6 milioni. Di fatto, nel corso della guerra, l’Italia riuscì a importare poco più di 1 milione di tonnellate di combustibili liquidi all’ anno. Queste cifre danno la misura del fallimento del progetto autarchico nel campo dei carburanti e della assoluta irrazionalità della scelta compiuta di entrare in guerra.
Ho detto qualche riga più su che con il decreto del luglio del 1937 il CNR si conquistò l’autonomia. Esso fu riconosciuto alle dirette dipendenze di Mussolini come organo scientifico-tecnico consultivo. L’intera struttura dell’ente venne modificata, vennero assunti dipendenti, si ricostituirono i Comitati ed il direttorio. Nel dicembre del 1937 era morto Marconi e il generale criminale Pietro Badoglio era stato chiamato a succedergli alla presidenza del CNR essendo anche capo di stato maggiore generale, massimo esponente delle forze armate (Badoglio mantenne la carica fino al 1941 quando la passò al generale di marina Giancarlo Vallauri che la mantenne fino al 1943 per passarla a Francesco Giordani che la mantenne fino al 1944). Era stato un altro discorso di Mussolini (11 ottobre 1937) a dare questa nuova speranza al CNR. In tale intervento Mussolini aveva detto che era ora di passare dai piani preparatori alla effettiva realizzazione dell’autarchia. Partì subito la propaganda del nuovo corso fatta con trasmissioni radio aperte da Badoglio con, tra l’altro, queste parole:
Questa parola “autarchia”, usata da Lui una prima volta nel senso di “autonomia economica”, ha assunto in poco tempo un significato inequivocabile – vorrei dire “magico” – e corre sulle bocche di tutti, tecnici e profani, come una parola di ordine che non ha bisogno di spiegazioni. In questa facoltà sovrumana, di conferire a una parola fino a ieri trascurata, una improvvisa e definitiva illuminazione, il genio del grande Uomo di Stato si incontra con il genio del poeta.
Nonostante questa dedizione le speranze del Duce andarono deluse perché il CNR non divenne mai un organo utile all’esercito e non per sua volontà ma per quella dell’esercito medesimo. Gli ufficiali non ebbero mai nulla chiedere e fecero addirittura cadere le ricerche avviate da Marconi per il rilevamento di oggetti in movimento (qualcosa che preludeva al radar e che la propaganda sciocca di un giornalismo sempre servile definiva il raggio della morte. Da qualunque parte la si osservi e qualunque possa essere la posizione ideologica, se esiste ancora, è certo che l’Italia non era assolutamente in grado di affrontare una guerra.
I risultati, a fronte di finanziamenti che erano arrivati intorno ai 20 milioni di lire, furono molto scarsi se tra essi si annoverano i successi del Centro Sperimentale per le applicazioni della psicologia fondato nel 1940 da Padre Agostino Gemelli, grande fascista e firmatario del Manifesto della razza (9). Il problema dei finanziamenti era comunque, come tutto, non risolto perché aleatorio. Non ci si poteva contare in una programmazione perché interveniva il Duce o chi per lui e facilmente come rapidamente cambiava le carte in tavola.
Si potrebbe a questo punto entrare nei dettagli di cosa fu fatto davvero in quei pochi anni di presidenza Badoglio ma sono davvero dei dettagli che non meritano attenzione nell’economia di questo scritto (dettagli che si possono però trovare nel più volte citato libro di Maiocchi 2003). Ciò che emerge con chiarezza è da una parte la disponibilità degli scienziati che abbiamo incontrato di collaborare con il regime fascista e dall’altra l’incapacità degli uomini di tale regime di organizzare il lavoro di un ente che avrebbe potuto fare o comunque comunicare cosa non era fattibile. Sullo sfondo un’industria ottusa che abbondava di spirito patriottico e di sostegno all’autarchia ma solo per massimizzare i profitti e per scaricare tutti gli oneri allo Stato, senza rischiare una lira in proprio. Gli scienziati, per parte loro andavano anche al di là di quanto loro veniva richiesto, inventandosi dati solo per far felice il Duce. Così Francesco Giordani riusciva a scrivere le cose seguenti senza provare alcuna vergogna:
la rassegna delle disponibilità nazionali di ferro, sia sotto forma di minerale, sia sotto forma di rottami, conduce a valutare una disponibilità complessiva paci al 67 per cento del fabbisogno; una percentuale cioè più alta di quella di cui dispongono la Germania e l’Inghilterra, considerati come paesi tradizionalmente siderurgici.
Tutto finì come tutti sanno e cioè molto male innanzitutto per le premesse idiote di cercare guerre quando vi era la gran parte d’Italia da sistemare ed organizzare e poi per l’incapacità del regime di cogliere le potenzialità della scienza se solo si pensa che furono fatti emigrare le migliori menti d’Italia su politiche bestiali per le quali ogni italiano, soprattutto chi oggi ha cambiato idea diventando une stimatore degli ebrei, dovrebbe vergognarsi per aver permesso che tale classe politica assurgesse al potere. Ma, guardandosi in modo disincantato intorno e con un’altra montagna di rammarico, osservo che nulla è mutato ed oggi si continua sulla stessa strada magari cambiando i nemici in corso d’opera ma con gli stessi ignoranti al potere con il solito codazzo di adulatori e di giornalisti bugiardi e distesi a tappetino. Tutto cominciò di nuovo dal dopoguerra quando sembrava che la Liberazione avesse fatto una qualche pulizia. Invece, ad esempio, si ricominciò con gli stessi uomini in tutte le istituzioni ed i poteri dello Stato. Quel Giordani ora citato, ad esempio, fu chiamato alla Presidenza del neonato Consiglio Nazionale Ricerche Nucleari (CNRN) nel 1952 da De Gasperi (estimatore di Graziani). Mantenne tale incarico fino al 1956 quando passò alla Presidenza del CNR, incarico che mantenne fino al 1960 quando ormai era prossimo a lasciarci.
Roberto Renzetti
NOTE
(1) La chimica della cellulosa consiste in differenti trattamenti a cui sono sottoposte alcune piante annuali (ma anche il legno) per sottrarre loro la lignina ed altri componenti non cellulosici al fine di ottenere fibre singole che possono essere spappolate in acqua.
Per ottenere combustibili liquidi non derivati da petrolio (ad esempio dal carbone) furono sviluppati differenti processi chiamati di idrogenazione (utilizzati anche per migliorare la qualità dei prodotti derivati da petrolio). Tali processi consistono nel trattare differenti sostanze con idrogeno ad alta pressione e temperatura ed utilizzando opportuni catalizzatori. Si noti che l’idrogenazione permetteva anche di liberare il carbone dallo zolfo e questa eventualità, nel caso della bassa qualità del carbone italiano, era molto ricercata dalla nostra industria.
Come ricorda Cerruti, negli anni Trenta del Novecento, il tedesco Franz Fisher ed il cecoslovacco Hans Tropsch avevano ottenuto combustibili per motori a scoppio facendo passare vapor d’acqua su catalizzatori a base di ossidi metallici. Lo sforzo bellico tedesco fu in gran parte sostenuto dal processo industriale che nacque da questa tecnica. In Italia, invece, riferendosi alla distillazione della lignite ed ancora nel 1935, Ernesto Sospisio sosteneva che per noi non presenta un grande interesse industriale, malgrado le molte speranze nate in merito all’idrogenazione e la trasformazione del fossile in carburante.
(2) Occorre ricordare che nel 1921 scienziati e gli industriali facenti capo ad un sopravvissuto Comitato scientifico-tecnico, creato in tempo di guerra, riuscirono a imporre uno scienziato al Ministero della Pubblica Istruzione (allora Ministero dell’Educazione): Orso Mario Corbino. Se solo si pensa che egli succedeva a Benedetto Croce, ci si può render conto del mutato peso specifico della ricerca scientifica in Italia. Nel 1923 (primo governo Mussolini) Giovanni Gentile subentrò alla pubblica istruzione ma Corbino rimase ministro, senza essere (ne lo fu mai) iscritto al PNF. Con Gentile prese il via la riforma della scuola che, in gran parte, è ancora quella che avevamo fino alla sua distruzione da parte di Berlinguer e Bassanini. Ma vanno sottolineati il prestigio e il potere che continuavano a circondare Corbino.
(3) L’ignoranza sugli argomenti era completa e i discorsi dei più avveduti (Croce e Gentile) erano vaghi e privi di riferimenti specifici. Il passaggio ai meno avveduti portava al ridicolo. Ad esempio, Ardengo Soffici, su “Gerarchia”, inveisce contro la relatività di Einstein perché essa negherebbe il fascismo in quanto quest’ultimo poggia su verità ‘assolute’ come “Dio, Patria, Famiglia, Autorità, Ordine, Italia vittoriosa, …“. Come si vede, la confusione e l’ignoranza, se non fossero tragiche, sarebbero ridicole. Per completezza va detto che, per quanto paradossale possa apparire, la filosofia accademica si schierò a sostegno della relatività, in quanto era un ottimo argomento a sostegno dell’idealismo dominante.
(4) I chimici erano particolarmente sensibili al problema. Se da una parte ancora aspettavano cattedre applicative negli insegnamenti universitari (che pure già cominciavano a venire: nel 1923 il corso di chimica industriale diventa obbligatorio per il conseguimento della laurea in chimica e da allora si iniziano ad aprire vari corsi di laurea in chimica industriale), dall’altra erano coscienti che il grande balzo della chimica tedesca si era originato sugli studi teorici della chimica di fine Ottocento e particolarmente sui lavori di Kekulè, che trovò la formula di struttura del benzene. È interessante ricordare quanto, a proposito di matematica, sosteneva Mauro Picone (noto per il suo Trattato di Analisi scritto con Fichera) “Matematica applicata = Matematica fascista”.
(5) Poiché non se ne parla è utile, almeno in nota, dire qualcosa sulle mostruosità degli italiani nelle guerre d’Africa. La cosa è stata tenuta nascosta per molti anni ed i responsabili (tra cui Badoglio e Graziani) non sono stati mai processati dopo la Liberazione. Il nostro esercito utilizzò barbaramente sulla popolazione civile i gas (yprite e fosgene).
Dopo un tentativo fatto nel 1922 tra Italia, Usa, Gran Bretagna, Francia e Giappone per mettere al bando le armi chimiche e fallito per la non ratifica della Francia, nel 1925, per iniziativa della Società delle Nazioni, l’Italia ed altri 25 Paesi firmarono un trattato che bandiva l’uso di tali armi a meno che uno non dovesse utilizzarle per difendersi da un aggressore che le avesse utilizzate per primo. La ratifica italiana avvenne il 3 aprile del 1928 ed il trattato è ancora in vigore (gli USA non lo firmarono ed attualmente non lo riconoscono).
Nonostante ciò l’Italia (con Badoglio tra i fervidi sostenitori) utilizzò massicciamente gas contro la popolazione civile in Libia nel 1927-28 (ma tale uso già si era avuto nel 1923-24) e nel 1930 (ed un uso analogo si ebbe anche in Somalia a partire dal 1935, con il fattivo contributo di Graziani). Furono fatti preparativi negli anni successivi per l’aggressione all’Eritrea. Vi era un Servizio Chimico militare che lavorava con i gas oltre che con nebbiogeni e lanciafiamme che fu potenziato allo scopo di addestrare le truppe, fare esperienze ed esercitazioni. Una relazione del 1935 di un ufficiale del Servizio Chimico, E. Venditti, che aveva fatto sopralluoghi nelle zone da colpire in Eritrea così recitava:
Le caratteristiche essenziali dell’ambiente, costituite da periodi di lunga siccità e da elevate temperature, non consentono di impiegare con efficace rendimento gli aggressivi soffocanti (tipo fosgene, difosgene); riducono il rendimento di quelli lacrimogeni (cloro-picrina, cloroacetofenone), di quelli starnutatori (tipo difenilcloroarsina) e di quella vescicatori (tipo yprite, lewisite). […]
Le elevate temperature e le aspre anfrattuosità del terreno sono cause concomitanti di forti correnti ascensionali che rendono difficile la formazione di forti concentrazioni. In conseguenza, gli aggressivi avrebbero dovuto essere impiegati con densità maggiori di quelle previste per i teatri di guerra europei e per i vescicatori l’azione aggressiva sarebbe stata prevedibilmente limitata a quella per contatto del liquido, dovendo si ritenere nulla o quasi l’azione dovuta ai vapori, a meno di particolari conformazioni del terreno, […]
Proposi quindi di limitare l’impiego degli aggressivi ai seguenti: cloro-picrina, arsina, yprite distillata. […]
Proposi di mettere all’esame l’eventuale impiego, nell’interno del territorio etiopico, di culture batteriologiche contro parchi bestiame, pozzi, abitati (soprattutto durante la ritirata avversaria).
Il passaggio all’uso pratico con l’inizio dell’aggressione può essere riassunto con alcuni dati che riprendo da Del Boca.
Breve relazione sull’impiego degli aggressivi chimici da parte italiana durante la Campagna etiopica.
«Durante lo svolgimento delle operazioni culminate nell’occupazione di Addis Abeba nel maggio 1936, da parte di nostre squadriglie da bombardamento furono lanciate bombe ad yprite nel settore Nord e bombe ad yprite e fosgene nel settore Sud (Somalia) dell’ Africa Orientale. L’impiego fu più intenso nel settore Nord.
Il lancio avvenne dal dicembre 1935 all’aprile 1936, come risulta dalle seguenti tabelle:
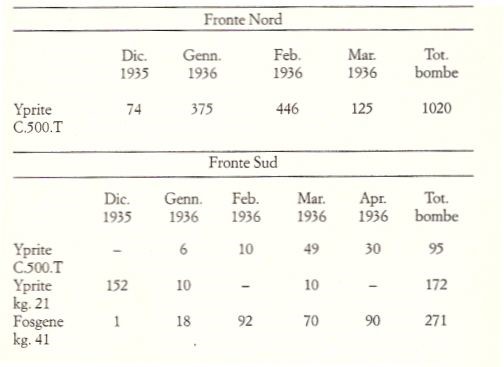
Le zone di lancio furono le seguenti:
Settore Nord: Selaclaca, settore del Tacazzè, settore del torrente Ghevà, settore del torrente Tsellari, zona dell’Endertà, carovaniera Makalle – Lago Ascianghi – Quoram; Settore Sud: zone di Sassabaneh – Bullaleh – Gunu Gadu – Uadarà – Ellot – Uaresa.
Durante le operazioni di grande polizia effettuate in novembre-dicembre 1936 nell’ovest etiopico furono lanciate complessivamente 24 bombe a yprite C.500.T nella zona ad ovest di Gimma ed a Gumma per circoscrivere l’attività di disturbo delle bande di ras Immiru contro le nostre colonne che procedevano all’occupazione dei centri più importanti della zona. Le ragioni che consigliarono l’uso degli aggressivi chimici durante quella Campagna vanno in gran parte ricercate anzitutto nella necessità di inibire alcuni passaggi obbligati al nemico, per impedirgli di effettuare manovre di aggiramento contro nostri reparti operanti in zone difficili, particolarmente adatte all’insidia e alle sorprese, e poi nella necessità di compiere rappresaglie per l’uso di pallottole dum-dum fatto dal nemico.
«Gli effetti dell’uso di aggressivi chimici furono quanto mai deleteri dal punto di vista materiale e morale. La scarsa resistenza organica degl’indigeni, denutriti, minati da malattie, fece sì che i casi mortali (accertati) raggiungessero alte percentuali».
Gli archivi non hanno dati posteriori al 5 maggio 1936 ma la consultazione di documenti diversissimi fa valutare in varie centinaia le bombe C.500.T lanciate nel 1937 e circa in 40 quelle utilizzate tra il 1938 e 1939, quando la direzione della Polizia coloniale erano dirette da Graziani.
Le esigenze di gas dello Stato Maggiore dell’Aeronautica per far bene le operazioni di Polizia con 50 missioni di 240 bombardieri erano quelle riportate nella tabella seguente:
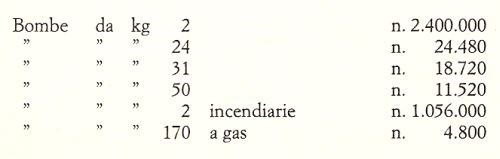
Ma gli studi su cosa si potesse fare di peggio fino ad arrivare alla tremenda C.500.T, proseguivano. La bomba a gas suddetta, insieme agli effetti dell’yprite, vengono così descritti da F. Pedriali nel testo di Del Boca:
Le prove ed i successivi perfezionamenti ottenuti in aprile 1935 dall’Ufficio Armamento debbono essere stati molto confortanti se riscontriamo dal verbale di una delle periodiche riunioni per «l’esigenza A.O.[Africa Orientale, ndr]» – quella tenutasi il 9 maggio presso lo Stato Maggiore generale – che il generale Valle informò Badoglio di avere disposto per la fabbricazione di ben 5.000 dalle nuove bombe «da 500 kg» caricate ad iprite, la cui spoletta a tempo «regolabile da bordo dell’ aereo» avrebbe consentito lo scoppio a 500 metri di quota relativa», irrorando sul terreno «un cerchio di diametro pari alla quota di scoppio». In realtà il quantitativo di bombe all’iprite inviato in Africa Orientale fra il settembre 1935 e l’estate 1936, non superò le 3.300 bombe, anche perché la disponibilità dell’iprite rimase limitata a 700 tonnellate, fra quantitativi a magazzino e di nuova produzione.
Alla fine di successivi studi ed esperienze, emerse una bomba ulteriormente perfezionata che fu prodotta e spedita ai reparti in Africa Orientale. Il modello finale fu denominato C.500.T ove il suffisso T indicava la spoletta a tempo, C stava per Chimica e 500 indicava che le dimensioni esterne dell’ ordigno erano pari a quelle della bomba esplosiva da 500 kg. Quest’ultimo accorgimento semplificò sia la costruzione della bomba sia le installazioni di lancio a bordo degli apparecchi da bombardamento – di cui i più moderni come i Ca.111, i Ca.133 e l’S.81 – uscivano dalle fabbriche già attrezzati per portare bombe da 500 kg. Ne conseguì una accelerazione di tutti i tempi di realizzazione del progetto.
La C.500.T conteneva due cariche: una di 212 kg di iprite ed una di 1,5 kg di tritolo. Il suo peso totale era 280 kg. La spoletta era regolabile a terra variando il passo della elichetta fissata sulla sua sommità. A seconda del passo scelto, variava il tempo in cui, sotto l’azione del vento di caduta, la rotazione dell’ elica liberava il percussore azionante la carica esplosiva, che faceva deflagrare la bomba aeroso1izzando l’aggressivo chimico. Il punto di mira doveva essere calcolato rilevando preventivamente la direzione del vento al suolo, mediante il lancio di una speciale bombetta fumogena. La esatta quota relativa al suolo dell’aereo veniva determinata osservando la caduta di una seconda bombetta di prova avente le stesse caratteristiche balistiche della C.500.T. Nel calcolo dell’angolo di lancio entravano la quota e la velocità dell’ aereo rispetto al terreno. […]
«I vapori [dell’aggressivo chimico] – precisava il manuale distribuito ai reparti aerei italiani – sono dannosi solo in forti concentrazioni che è difficile ottenere mediante l’impiego della bomba C.500.T». La fine pioggia prodotta dalla bomba poteva essere immediatamente efficace se ricadeva su esseri animati, ma una volta raggiunto il suolo, la sua efficacia era ristretta ad una zona più piccola all’interno dell’ ellisse di dispersione [avente dimensioni medie di metri 650 per 150] che rimaneva impraticabile per un paio di giorni. Tuttavia, poiché le dimensioni di questa zona veramente impraticabile erano esigue, per ottenere «sbarramenti» efficaci occorreva il lancio di più bombe sulla stessa area per sovrapporne gli effetti.
Basta un rapido cenno alle caratteristiche dell’iprite per comprendere i limiti di efficacia della C.500.T. In concentrazioni di 0,15 mg per litro d’aria, l’iprite è letale in 10 minuti. Ne consegue che la C.500.T doveva essere letale solo per coloro che rimanevano sotto il suo cono di esplosione per buona parte del periodo di ricaduta dell’aggressivo. L’odore dell’iprite è invece percettibile con 0,0007 mg per litro d’aria, mentre il limite inferiore di irritazione è 0,02 mg/litro d’aria. È quindi abbastanza facile evitare una zona contaminata, perché l’iprite è percettibile quando la sua concentrazione nell’aria è 28 volte inferiore al limite di irritazione. Nelle concentrazioni dovute o per contatto diretto, l’iprite produce lesioni su pelle e mucose, gravi, dolorose e di difficile guarigione. Non causa dolore al contatto immediato, ma agisce sulla pelle lentamente (da 1 a 12 ore) anche attraverso abiti, cuoio e caucciù. Pertanto è buona norma gettare al più presto gli indumenti infettati. Per la difesa passiva occorrono maschere e indumenti di tipo speciale.
L’iprite mantiene le sue capacità aggressive per un periodo variabile da uno a otto giorni. Però è idrosolubiile, quindi una buona pioggia bonifica rapidamente la zona colpita. Le lesioni dell’iprite, se curate, sono raramente mortali. L’azione dell’ aggressivo sulla parte colpita si neutralizza con cloruro di calce o soluzioni di permanganato potassico, oppure con lavaggi d’emergenza di alcool, etere, benzene, acqua calda e sapone. Una procedura poco sofisticata, ma alcuni di questi prodotti non erano sempre disponibili presso le armate etiopiche, assistite da poche seppure bene attrezzate unità sanitarie internazionali. Gli etiopici disponevano anche di piccole quantità di pomate neutralizzanti, con istruzioni in amarico corredate da figure esplicative, di cui alcune confezioni furono catturate dagli italiani.
Un opuscolo distribuito nel 1936 dal Servizio chimico militare del R.E. precisava che l’iprite «nel campo tattico può essere impiegata nella difensiva per creare un ostacolo e nella offensiva per rendere intenibili zone di terreno nelle quali non si vuole andare. L’ostacolo chimico però non è insuperabile; può essere inavvertitamente superato da chi non lo conosca, consentendogli di combattere per qualche ora prima di risentirne le conseguenze, come può essere superato da chi ben lo conosca, impiegando mezzi di ripiego semplici senza quasi riportare danno». A parte il rivelatore odore di senape, il manuale consigliava di osservare la presenza di goccioline e chiazze sul terreno e piccole macchie giallicce sulla vegetazione. Per attraversare il terreno ipritizzato, veniva suggerito di creare un sentiero gettando a terra mantelline, ramaglia, sassi e zolle di terra. Aggiungiamo che la persistenza dell’ aggressivo usato in A. O. era minima su terreno roccioso e che con una densità di 200 grammi di prodotto per metro quadro di terreno, a 25°C di temperatura ambiente – e naturalmente senza piogge – la durata dello sbarramento era di circa un paio di giorni.
Le due prime bombe C.500.T impiegate in Africa Orientale vennero lanciate a titolo di prova da un Caproni Ca.111 su una valletta del Beles nel mattino del 22 dicembre 1935, per verificare il funzionamento delle spolette in previsione dell’ attacco da portare nel pomeriggio sul passo di Dembeguinà con sei C.500.T. All’indomani i guadi del Tacazzè furono pesantemente attaccati dai Ca.111 dell’8° Stormo con 37 bombe C.500.T. Di queste però solo 28 si staccarono dai ganci, delle quali 19 esplosero regolarmente in aria mentre le altre deflagrarono al suolo. Quindi alla prima missione importante quasi metà delle nuove armi accusarono malfunzionamenti. Il fatto era però prevedibile per due fattori. Il primo era la fretta con cui le C.500.T erano state progettate e sperimentate. Il secondo era la diversità dell’ambiente africano da quello in cui le bombe erano state sviluppate. Simili inconvenienti si erano verificati anche per il munizionamento di caduta in dotazione da lungo tempo. Le bombe da 15 kg e gli spezzoni da 2 kg – ovvero i tipi destinati al maggiore impiego – avevano accusato alte percentuali di fallite esplosioni – rispettivamente del 18 per cento e del 16 per cento – durante le esercitazioni effettuate dai reparti aerei appena arrivati in A.O. I difetti avevano potuto essere eliminati prima dell’inizio delle ostilità perché erano stati rilevati in aprile. Un mese in cui le C.500.T erano ancora in piena fase di gestazione.
Comunque, i difetti al sistema di sgancio delle bombe al1’iprite erano lievi, più che altro questione di taratura di facile rimedio. Infatti nelle azioni immediatamente successive lo sgancio prese a funzionare abbastanza regolarmente, non altrettanto le spolette a tempo, pertanto un’ alta percentuale di bombe continuò a deflagrare al suolo perdendo molto della loro efficacia.
Riporto di seguito alcune foto:

I nostri valorosi soldati posano con una bomba ad yprite

Il generale dell’aviazione Vincenzo Magliocco, uno dei massimi responsabili dei bombardamenti terroristici all’yprite
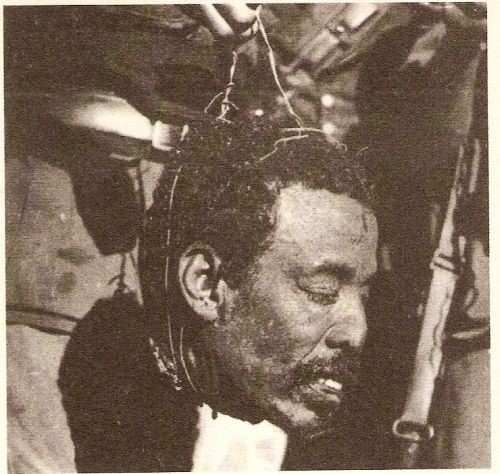
Altre atrocità degli italiani brava gente: il degiac Hailù Chebbedè, patriota e resistente all’invasione italiana, viene oltraggiato con la testa mozzata e portata in giro per i mercati etiopici perché venga vista dai cittadini.
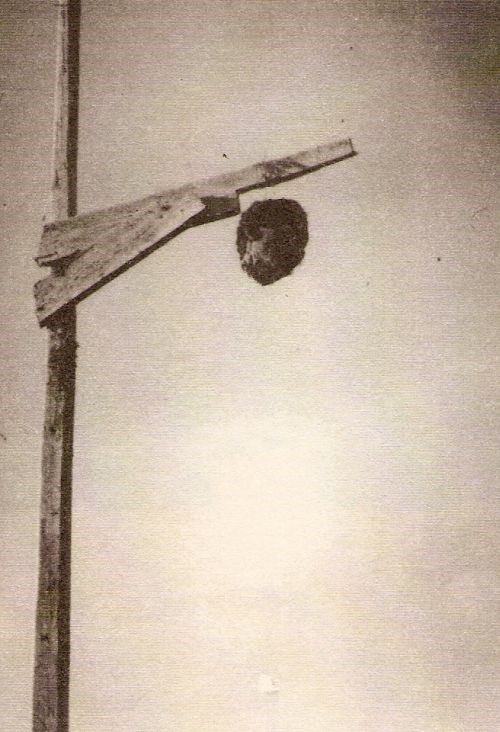
La testa del degiac Hailù Chebbedè issata su un palo al mercato di Quoram
Di seguito alcuni dei telegrammi con i quali Mussolini in persona ordinava le peggiori atrocità:
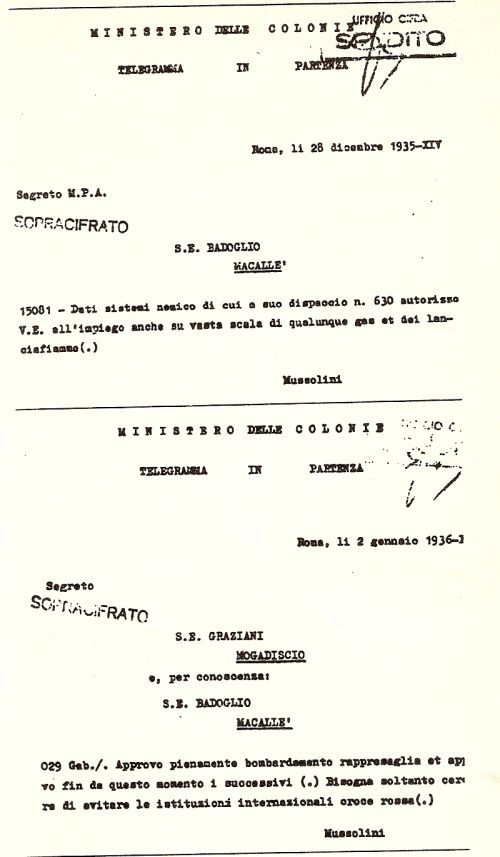
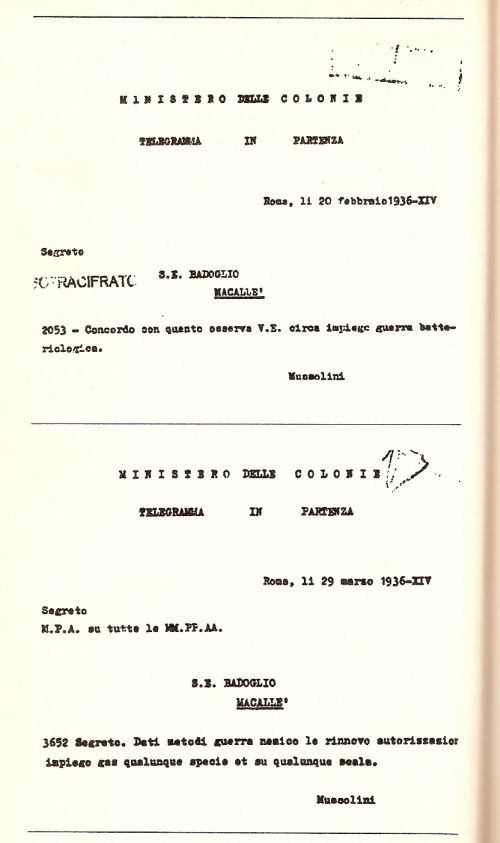
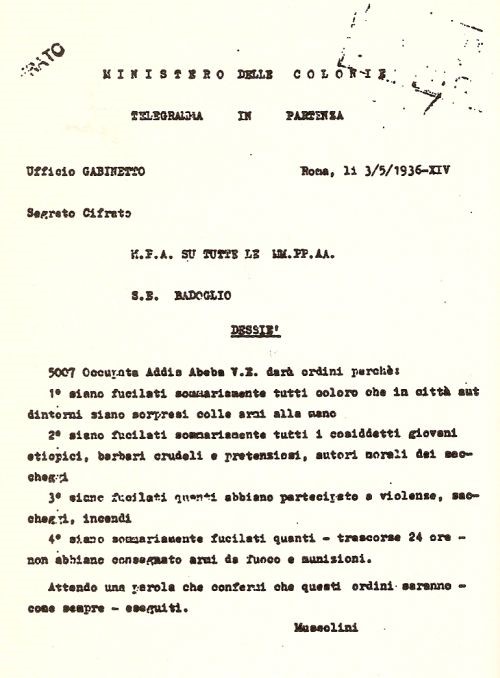
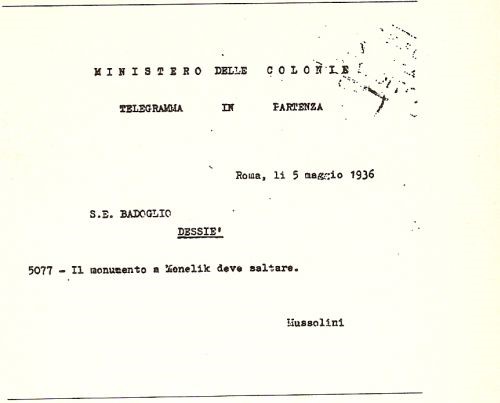
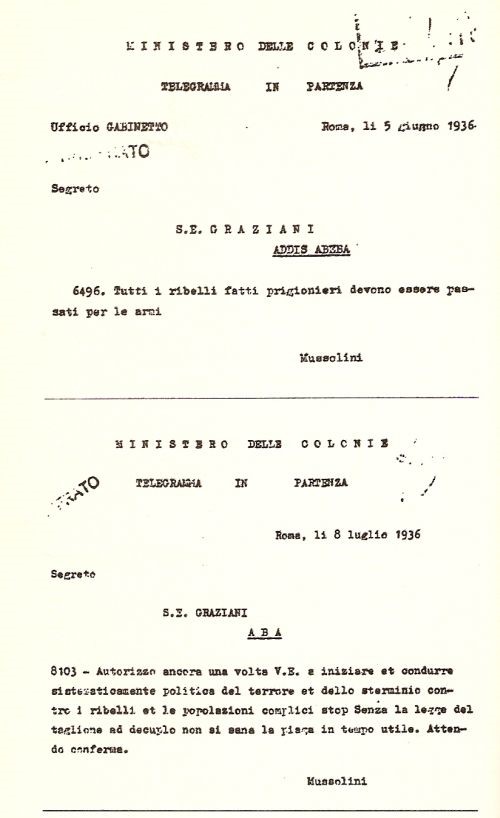
Questi documenti, tutti tratti da Del Boca che ne pubblica molti di più, sono venuti alla luce, in Italia, nel 1996. Erano a conoscenza degli stati maggiori dell’esercito italiano. Inoltre erano conosciuti dalla Gran Bretagna e quindi dagli USA. Il ruolo criminale di Graziani e Badoglio (ma anche di altri generali su altri fonti, come Roatta) era noto agli americani che liberavano l’Italia insieme ai nostri partigiani. Mentre in Germania si fece il Processo di Norimberga, in Italia non accadde nulla e questi criminali morirono a letto (ricordo che Graziani, tornato al suo paesello vicino al mio, Arcinazzo Romano, fu omaggiato da Andreotti che venne appositamente in questo bel paesino per abbracciare Graziani). Consiglio di leggersi la storia dell’OSS (servizi americani poi diventati CIA) in Italia e come arruolò sul finire della guerra i peggiori criminali sia mafiosi che fascisti (tra di essi Junio Valerio Borghese) per fare argine al pericolo comunista.
(6) Le sanzioni furono decise dalla Società delle Nazioni l’11 ottobre del 1935, una settimana dopo l’aggressione all’Etiopia. Esse comprendevano l’embargo sulle armi e le munizioni,, il divieto di prestiti e dell’apertura di crediti, il divieto di importare merci italiane, e di esportare in Italia merci che avrebbero potuto avere un qualche uso bellico. Entrarono in vigore il 18 novembre del 1935 e saranno abolite il 4 luglio del 1936, ad aggressione finita (almeno formalmente).
(7) La metadinamo è una macchina speciale a corrente continua costituite da un rotore e da un collettore come le dinamo ma con un maggior numero di spazzole distanziate da loro (in gradi elettrici) in modo diverso da quanto non lo siano in una dinamo (180 gradi elettrici). Ciò indica che le possibilità costruttive delle metadinamo sono innumerevoli.
“Ma vi sono ancora delle differenze rispetto alle normali macchine a corrente continua: ad esempio, nelle metadinamo il flusso magnetico generato dagli avvolgimenti di rotore è da considerare principale: agli avvolgimenti statorici il compito di modificare questo flusso e quindi di dare alla macchina ulteriori caratteristiche particolari.
Si può affermare quindi che la metadinamo è la macchina rotante a corrente continua più generale: con due file di spazzole, per ogni ciclo, essa si riduce infatti alla ordinaria macchina a corrente continua.
Le metadinamo possono essere classificate, in base alle trasformazioni energetiche fondamentali che in esse avvengono, come segue:
1) metadinamo trasformatrice, detta anche rnetatrasformatore, quando la macchina trasforma energia elettrica in altra energia elettrica, avente però caratteristiche differenti;
2) metadinamo generatrice, denominata anche metageneratore, quando la macchina fornisce energia elettrica per conversione di energia meccanica;
3) metadinamo motrice, denominata anche metamotore, quando converte energia elettrica in energia meccanica.
Le metadinamo, in conseguenza della loro natura così completa, riescono a risolvere brillantemente molti problemi, in particolare alcuni di quelli connessi con l’industria pesante e con gli armamenti”. [Da Mario Pezzi – Macchine elettriche – Zanichelli 1971].
(8) Riporto in proposito il paragrafo che Maiocchi (2003) dedica alla questione:
Per tutto il periodo della guerra d’Africa e dell’autarchia il regime fascista si preoccupò di esercitare un’azione propagandistica intensa, capillare, martellante, utilizzando i mezzi e le occasioni più svariate. Gli scienziati ebbero un ruolo di primo piano in questo lavoro, fornendo, con la loro adesione pubblica ai programmi, alle iniziative, alle celebrazioni del governo, del partito, delle corporazioni, delle istituzioni una potente copertura di razionalità scientifica. Vi fu una saldatura pubblica senza incrinature tra le parole d’ordine della guerra e dell’autarchia, da una parte, e le ragioni della scienza e della tecnica, dall’altra, saldatura che rappresentò nell’immaginario collettivo le imprese che appaiono le più irragionevoli alla stregua di dettati della scienza e della tecnica più avanzate. L’ideologia del nazionalismo scientifico-tecnico raccontata nelle pagine precedenti si trasformò con l’inizio della guerra in un atteggiamento bellicoso e arrogante che si esprimeva in discorsi e scritti con i quali i nostri maggiori scienziati divennero tribuni, garanti entusiasti delle scelte politiche di fondo del governo e ufficiali di un disciplinato esercito di ricercatori. Gli esempi sarebbero moltiplicabili a piacere, ma basterà qualche cenno per dare un’idea generale del clima di consenso che la guerra generò in molti esponenti della comunità scientifica.
Luigi Rolla, chimico di statura internazionale, in precedenza sempre moderato nelle sue esternazioni, in periodo sanzionistico così si esprimeva:
Mentre infuria la folle bufera scatenata contro l’Italia in nome di principii che sono nel più stridente contrasto cogli inconfessati moventi che ispirano atti e parole di coloro che rappresentano quell’impero che esercita l’egemonia più vessatoria sul mondo, la propaganda per il prodotto italiano è rivolta soprattutto alle industrie chimiche. I nostri chimici, inquadrati nelle loro corporazioni, si prefiggono di reagire nel modo più efficace liberando il Paese dal1’asservimento straniero, utilizzando tutte le risorse della nostra terra; e l’università italiana, che vanta le più gloriose tradizioni del mondo, guida e disciplina i nobili sforzi dei tecnici, formando le menti e temprando i caratteri.
Domenico Meneghini, esperto dell’industria zuccheriera e alcooligena:
I biliosi censori ginevrini nulla potranno, con le loro inique sanzioni, contro questa industria fiorente che trae la sua origine dai campi bonificati, dal sole e dal paziente e sapiente lavoro umano, e dà alla Patria in mille rivoli: energia di carboidrati, di carburanti e di esplodenti, e nulla ha da chiedere all’estero, ma ad esso forse avrà qualche cosa da insegnare.
Giovanni Morselli, personalità eminente nel campo delle ricerche e delle realizzazioni farmaceutiche, celebrava la proclamazione dell’Impero senza risparmiarsi:
I chimici italiani fascisti, ferventi patrioti per nobilissima tradizione, salutano coll’animo gonfio di commozione e di orgoglio l’aurora dell’Impero. Innalzano il loro pensiero al Re vittorioso imperatore di Etiopia, simbolo glorioso della Patria immortale, gridano il loro sconfinato amore al Duce fondatore dell’Impero, genio purissimo, espresso fatidicamente dalle profonde, arcane virtù creatrici della razza. I chimici italiani consapevoli della potenza costruttiva della loro scienza, nelle sue proteiformi possibilità applicative, fieramente aspirano di partecipare alla nuova fatica che attende il popolo italiano, per fecondare l’Impero.
Trattando della metallurgia Livio Cambi traeva spunto per attaccare:
le pingui borghesie straniere, i superati ideologi delle nazioni che tentano di sabotare le nostre vittorie, [i quali] questo non potevano prevedere: contavano sulla modestia del nostro potenziale industriale! Non possedevano però, e non posseggono il metro per misurare questa passione e questa coscienza, questa nostra mistica dedizione alla Patria, che il Duce ha suscitata, traendola dall’anima millenaria della nostra razza.
Chiaro, chiarissimo, in particolare era il nesso che era venuto a instaurarsi definitivamente tra sviluppo dell’ economia autarchica e preparazione a una nuova guerra. Parravano assicurava che «gli italiani considerano l’attrezzatura autarchica della Nazione come un necessario completamento dell’attrezzatura militare, e daranno tutte le loro energie per completarla e mantenerla in piena efficienza». Francesco Giordani gli faceva eco:
L’esame delle condizioni storiche, geografiche e politiche, della Nazione italiana conduce a concludere che per il nostro Paese l’unica via da seguire è quella consistente nel ridurre al minimo possibile l’importazione di materie prime, anche perché il futuro piano regolatore dell’economia nazionale dovrà essere dominato, secondo il comandamento del Duce, dalla fondamentale premessa della ineluttabilità che la Nazione sia chiamata al cimento bellico.
Sarebbe un errore ridurre questi esempi, e tanti altri similari, a semplici ripetizioni di parole d’ordine provenienti dall’ alto, poiché di tali parole d’ordine alcuni nostri importanti scienziati erano, almeno in parte, i responsabili. Quando l’ideale autarchico era indicato come nobile e possibile da un Giordani in riferimento alla cellulosa, da un Cambi per i metalli non ferrosi, da un Oscar Scarpa per l’alluminio, da un Mario Giacomo Levi per i combustibili nazionali, da un Morselli per i medicinali, per non parlare di un Parravano, di un Fantoli, di un Bruni, ebbene costoro parlavano sostanzialmente dei propri studi, della propria attività scientifica c organizzativa, non ripetevano ma lanciavano parole d’ordine che essi avevano contribuito a creare.
Attorno a questi protagonisti della nostra vita scientifica si organizzò il coro dei ripetitori ossequiosi, delle personalità scialbe che trovavano comodo seguire la corrente. Difficilissimo è, naturalmente, valutare in termini quantitativi e qualitativi il consenso degli ambienti scientifici e tecnici ottenuto dal lancio del progetto autarchico. Si può certo a priori sostenere che nel determinare gli atteggiamenti pubblici l’opportunismo giocò un ruolo importante, ma non credo si debba escludere la presenza di sacche di persone che nell’ autarchia videro una reale occasione di razionalizzazione e di progresso della struttura produttiva italiana: basti pensare al caso sopra ricordato di Henry Molinari [un antifascista noto al fascismo ma lasciato lavorare per le sue grandi capacità di chimico, ndr], Su questo si dovrà comunque ritornare. Certo esistono segni inequivocabili che, al di là delle motivazioni dei singoli, la partecipazione di scienziati e tecnici alle iniziative pubbliche del regime nel 1936 fu notevolissima e di grande effetto scenografico. La manifestazione più impressionante fu quella che si ebbe in occasione della riunione annuale della Società italiana per il progresso delle scienze (SIPS) che, a celebrare l’Impero, si tenne a Tripoli dal l° al 7 novembre 1936 sul tema Il problema imperiale italiano con Enrico Fermi infaticabilmente assiso al tavolo della presidenza. Ben 500 congressisti affrontarono il non agevole viaggio per essere presenti a un evento che assunse le tonalità di una trionfale parata militare. Ecco come gli atti ufficiali della SIPS descrissero la prima giornata della riunione:
Nel fulgore di una giornata quasi primaverile, in una atmosfera di vibrante entusiasmo, Tripoli si è svegliata al suono delle bande e delle fanfare e al canto degli inni della Patria e della Rivoluzione che i goliardi, i giovani fascisti, gli avanguardisti facevano echeggiare per le vie cittadine recandosi dalle sedi ai luoghi di adunata, per poi confluire nel Reale Teatro di Miramare […]. Le rappresentanze di tutte le Forze Annate, facenti parte del Regio Corpo delle Truppe Coloniali, affluivano dalle caserme ai luoghi stabiliti, per rendere gli onori a S.A.R. il Duca d’Aosta, che in forma ufficiale e in rappresentanza di S.M. il Re Imperatore, avrebbe assistito alla solenne cerimonia inaugurale. Dalla villa della Bu-Setta, residenza dell’ Augusto Principe, fino al Reale Teatro Miramare, presto le truppe sono schierate in attesa del passaggio del Duca, e dietro i cordoni si affolla la cittadinanza che vuole esprimergli la sua gioia di rivederlo in Libia. Intanto, da Corso Vittorio Emanuele III, da Corso Sicilia, dal Lungo mare Conte Volpi, tutta la cittadinanza affluisce nelle adiacenze del Reale Teatro Miramare, ma nell’interno del teatro non tutti possono prendere posto, e molti debbono accontentarsi di attendere fuori l’arrivo del Principe […]. Alle 10 la sala del Miramare è al completo, e presenta un suggestivo colpo d’occhio. Nella platea sono tutti i congressisti, che indossano la divisa fascista, e nei palchi hanno già preso posto tutte le gerarchie della Colonia. La galleria pullula della gioventù fascista della Colonia: giovani fascisti, avanguardisti, giovani italiane, che fanno echeggiare il teatro di canti e di acclamazioni all’indirizzo del Duce. Il grido Duce! Duce! Duce! echeggia nel teatro, e subito il canto degli inni della Rivoluzione succede alle acclamazioni […]. La sala presenta un grandioso spettacolo: gli uomini di scienza si uniscono alle manifestazioni di entusiasmo dei giovani, e acclamano con loro all’indirizzo del Duce fondatore dell’Impero […]. La fanfara dei Giovani Fascisti suona gli inni della Patria che vengono cantati a gran voce dai giovani, cui si uniscono i congressisti. Le acclamazioni al Re Imperatore e al Duce si incrociano e si susseguono, unite agli alalà all’indirizzo dell’Augusto Principe Sabaudo che sta per arrivare e al Maresciallo Balbo. Intanto, per le vie imbandierate, la folla dietro i cordoni acclama S.A.R. il Duca d’Aosta che, col Maresciallo, preceduto e seguito da un plotone di zaptiè in bumus rosso e da uno squadrone di savarì in alta uniforme si reca in forma ufficiale alla cerimonia. Dal Castello si iniziano le salve di uso, e lungo tutto il percorso, dalla Bu-Setta al Miramare, le truppe schierate rendono gli onori. Il suono della Marcia Reale e Giovinezza fa scattare in piedi sull’ attenti le autorità, i congressisti ed il pubblico che affollano il teatro: S.A.R. Amedeo di Savoia fa il suo ingresso nel palco governatorale, e la folla Gli tributa una prolungata dimostrazione di simpatia.
La scienza italiana era diventata un pezzo basilare della macchina mediatica del regime.
(9) Riporto il paragrafo di Maiocchi (2003) delle conseguenze delle leggi razziali sul personale operante nel CNR:
Durante la presidenza Badoglio anche il CNR, come tutte le istituzioni italiane, dovette confrontarsi con i problemi sollevati dalla legislazione razzista. Subito dopo la pubblicazione del celebre Manifesto degli scienziati razzisti, il 14 luglio 1938, Giovanni Preziosi, l’intellettuale italiano che poteva vantare la più lunga militanza nelle file dell’antisemitismo, dalle pagine della sua rivista, “La Vita italiana“, accusò il CNR di essere un ricettacolo di ebrei, facendo il nome di 12 “giudei” facenti parte del consiglio. Il ministro della Cultura popolare «d’incarico del Duce» inviò l’articolo di Preziosi a Giannini in data 23 luglio e questi rispose nel giro d’una settimana con un promemoria per Mussolini. In esso Giannini comincia a depennare dall’elenco di Preziosi chi ebreo non era, come Lo Surdo, chi non apparteneva al CNR ma era prestato da altre amministrazioni (come l’autista del segretario generale), prosegue sottolineando che 2 dipendenti ebree «sono maritate ad ariani» e che, in fondo, su un totale di 204 membri dell’istituzione 7 ebrei (di cui 2 spose felici di ariani) sono una percentuale non certo alta, e conclude riservandosi «di svolgere opportune indagini per accertare se vi siano altri ebrei fra il personale del Consiglio». Il mese successivo Preziosi ritornò all’attacco pubblicando gli elenchi dei componenti ebrei dei consigli direttivi dei comitati nazionali e Giannini fu costretto a rispondere nuovamente, questa volta non potendo smentire neanche parzialmente “La Vita italiana” e limitandosi a far presente che i nomi erano tra i più grandi della scienza italiana ed erano stati approvati tutti da Mussolini. Preziosi aveva anche lanciato 1’accusa al segretario generale Frascherelli di essere un massone, quindi sospetto filosemita, e Frascherelli si affrettò a scrivere ad Achille Starace, per chiedergli di difenderlo dalle accuse calunniose, «sembrandomi che all’autorità suprema di chi guida il Partito non possa essere sottratto il giudizio sul contegno di un camerata, il quale vilipendia ingiustamente […] un altro camerata» .
La questione della presenza degli ebrei nel CNR fu posta ufficialmente nel Consiglio di presidenza del 16 dicembre 1938, in cui fu decisa, senza che il verbale registri discussione alcuna, l’espulsione dai comitati nazionali di coloro che, «in conseguenza degli accertamenti circa la razza e la iscrizione al PNF», erano risultati non iscritti o ebrei. Lasciarono così il CNR 3 membri del Comitato dell’agricoltura (1 ebreo), 3 di quello di astronomia e geodesia (tutti ebrei), 7 (di cui 5 ebrei) di biologia, 5 (4 ebrei) di chimica, 6 (4 ebrei) di fisica, 5 (1 ebreo) di geografia, 3 (nessun ebreo) di geologia, 9 (5 ebrei) di ingegneria, 6 (tutti ebrei) di medicina, 3 (2 ebrei) di radiotecnica. L’unico comitato risultato completamente “sano” fu quello di geofisica e meteorologia. Il consiglio decise di chiedere al Duce se si potesse riammettere alcuni non iscritti «in considerazione della loro posizione nell’insegnamento o delle loro particolari benemerenze scientifiche, sempre che non ostino altre ragioni».
Il problema del razzismo fu posto come questione scientifica al CNR nell’ottobre del 1940, quando Sabato Visco, presidente di fatto del Comitato per la biologia, viste le condizioni di salute malferme del presidente nominale Filippo Bottazzi, nonché direttore, di fatto e di diritto, dell’Ufficio studi e propaganda sulla razza del ministero della Cultura popolare, dunque uno dei protagonisti del razzismo italiano, propose che il CNR istituisse un Commissione per lo studio dei problemi della razza per dare veste scientifica alla cultura razzista italiana:
Mentre le indagini sui problemi della razza erano piuttosto trascurate nel nostro Paese, a differenza di quanto avveniva specialmente in Germania e negli Stati Uniti d’America, subito dopo le dichiarazioni del Manifesto razzista (14 luglio 1938) sono sorti da un capo all’altro d’Italia numerosi cultori di studi razziali. Questa attività non coordinata, svolta il più delle volte da incompetenti, non solo non ha contribuito ad illuminare gli aspetti del grandioso problema che si prèsentava agli studiosi italiani, ma ha creato una confusione che ha disorientato il Paese. Ora appare necessario uscire da questa situazione, richiamare intorno allo studio di tali problemi persone di particolare competenza e coordinarne l’azione.
La commissione venne istituita, ma non sembra che poi abbia effettivamente lavorato.
BIBLIOGRAFIA
1) AA. VV. – La storia delle scienze – Bramante 1989
2) Roberto Maiocchi – Gli scienziati del Duce – Carocci 2003
3) Denis Mack Smith – Storia d’Italia. 1861-1969 – Laterza 1975
4) Sergio Romano – Storia d’Italia dal Risorgimento ai giorni nostri – Mondadori 1978
5) Rosario Romeo – Breve storia della grande industria in Italia. 1861-1961 – Cappelli 1974
6) AA.VV. – Storia d’Italia, Annali 3. Scienza e Tecnica – Einaudi 1980.
7) B. Caizzi – Storia dell’industria italiana – UTET 1965.
8) A. Rossi – Nascita dell’Italia scientifica – Sapere n. 3, marzo 1984.
9) A. Rossi – L’Italia scientifica durante il fascismo – Sapere n. 4, aprile 1984.
10) A. Russo – La scienza cocchiera dell’industria – SE (Scienza Esperienza) n. 11, 1984.
11) A. Brigaglia – La politica del regime nella ricerca – SE (Scienza Esperienza) n. 9, 1983.
12) S. D’Agostino – La fisica italiana tra le due guerre – Nuova Scienza n. 5, 1984.
13) AA. VV. – Storia d’Italia. Annali 3: Scienza e Tecnica – Einaudi, Torino 1980 (contiene il saggio di Roberto Maiocchi – Il ruolo delle scienze nello sviluppo industriale italiano).
14) Angelo del Boca – I gas di Mussolini – Editori Riuniti 1996.
15) Serafino de Capitani – Gli autoveicoli a carburanti nazionali (solidi, liquidi, gassosi) – Ulrico Hoepli 1940 – XVIII
16) AA. VV. – Energia e sviluppo. L’industria elettrica italiana e la società Edison – Storica Einaudi 1986
Categorie:Politica
Rispondi